| La Stampa | Giovedì 13 marzo 2014 | Massimiliano Di Pasquale |
Tag: Collana “inchieste”
-

“L’illusione degli ucraini sul nazismo durò solo qualche settimana”
Giovanna Brogi Bercoff, professore di slavistica all’Università di Milano, interviene sul tema delle politiche di russificazione dell’Ucraina Orientale intraprese dalla Russia zarista dopo la storica battaglia di Poltava del 1709: “Da allora resistono molti pregiudizi”Giovanna Brogi Bercoff, professore ordinario di slavistica presso l’Università di Milano, direttrice della rivista Studi Slavistici e presidente dell’AISU (Associazione Italiana di Studi Ucrainistici), parla della grave crisi tra Russia e Ucraina e aiuta a inquadrare le complesse vicende di queste settimane in un’ottica storico-culturale in cui grande peso hanno avuto le politiche di russificazione dell’Ucraina Orientale intraprese dalla Russia zarista dopo la storica battaglia di Poltava del 1709. (altro…) -

La verruca sul naso di Putin
| The Post Internazionale | Sabato 8 marzo 2014 | Massimiliano Di Pasquale |
L’opinione dell’autore di “Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta”È stato l’economista russo Andrei Illarionov, ex consigliere di Putin caduto in disgrazia per aver criticato la guerra del gas voluta dal Cremlino nel 2006 contro l’Ucraina arancione di Viktor Yushchenko, ad anticipare più di un mese fa alla tivù Hromadske TV lo scenario cui si sta assistendo in questi giorni in Crimea.
Se, come aveva dichiarato Illarionov, l’allora presidente Yanukovych non fosse riuscito a fermare con la forza la protesta di piazza, allora i russi sarebbero intervenuti direttamente con i carri armati. Lo schema sarebbe stato quello già visto in Georgia nel 2008. Milizie russe avrebbero cercato di provocare un incidente ad hoc contro un cittadino di passaporto russo, avrebbero poi incolpato dell’accaduto l’esercito ucraino e, con la scusa di proteggere la popolazione russa della Crimea, avrebbero quindi invaso la penisola ucraina.
In Ossezia del Sud nell’agosto del 2008 l’allora presidente Mikheil Saakashvili, ordinando al suo esercito di intervenire per porre fine ai bombardamenti di villaggi georgiani da parte delle forze separatiste ossete, offrì infatti il pretesto ai carri armati russi per invadere la Georgia. Oggi, a meno di una settimana dalla destituzione di Yanukovych del 22 febbraio e dalla nascita di un esecutivo ad interim presieduto dal premier Arseniy Yatsenyuk e dal presidente Oleksander Turchinov, Putin ha già inviato il primo contingente militare in Crimea, penisola che dal 1954 fa parte dell’Ucraina, violando la sovranità territoriale del paese.
Motivazione ufficiale, di quella che Kiev ha definito una grave provocazione e il preludio a un possibile conflitto armato tra Russia e Ucraina, “stabilizzare la situazione in Crimea e utilizzare tutte le possibilità disponibili per proteggere la popolazione russa locale da illegalità e violenza”. L’attività diplomatica internazionale – in particolare la dura reazione del presidente statunitense Obama che ha deliberato sanzioni economiche nei confronti di Mosca, il boicottaggio del G8 di Sochi e l’interruzione di tutti i legami militari con il Cremlino incluse le esercitazioni e le riunioni bilaterali – ha scongiurato per ora lo scoppio di una guerra.
Ciononostante a Simferopoli, il parlamento della Repubblica Autonoma Crimea, di concerto con le autorità russe, senza interpellare la Rada di Kiev, ha già indetto per il 16 marzo un referendum per chiedere la secessione dall’Ucraina e l’annessione alla Federazione Russa. A nulla sono valse le scomuniche espresse venerdì 7 marzo dal Consiglio straordinario dei 28 capi di stato e di Governo della Ue e dagli Stati Uniti che hanno definito illegittima la consultazione. La crisi di questi giorni tra i due paesi, la più grave nell’area post sovietica dal crollo dell’URSS, nasce dal successo di Euromaidan, la rivolta popolare che ha sconfitto il regime di Yanukovych, il quale nelle ultime settimane aveva assunto un volto sanguinario con l’uccisione di un centinaio di manifestanti.
Le dimostrazioni di Piazza dei mesi scorsi – che, pur avendo come epicentro Kiev, hanno interessato tutta l’Ucraina – sembrerebbero testimoniare la volontà degli ucraini di lasciarsi alle spalle l’epoca post-sovietica e di aprire una nuova fase: quella della rigenerazione morale. Questo ambizioso tentativo deve fare i conti al momento con due questioni: in primis, la volontà di Mosca di ostacolare un progetto che, se vittorioso, porrebbe la parola fine sull’Unione Euroasiatica e fornirebbe linfa vitale anche all’opposizione democratica russa; in secondo luogo, le difficoltà interne legate alla situazione economica del paese.
Affinché l’Ucraina possa vincere questa sfida occorre che Europa, Canada e Stati Uniti la sostengano finanziariamente con un piano mirato di prestiti e investimenti, e che la Comunità Internazionale garantisca con ogni mezzo la sua integralità territoriale ottemperando al memorandum di Budapest. Con quell’accordo, firmato il 5 dicembre 1994 nella capitale ungherese, l’Ucraina cedeva il suo arsenale nucleare in cambio della garanzia della tutela della sua sovranità e sicurezza da parte di Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti.
Se il Cremlino riuscisse infatti a creare un’enclave separatista in Crimea, ciò potrebbe innescare pericolosi effetti domino nell’est del paese. E quella che è stata finora la rivoluzione di un popolo contro un regime corrotto potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra civile qualora l’opera di destabilizzazione della Russia, attraverso provocazioni militari e disinformazione mediatica, avesse successo. Nel periodo della presidenza Putin, il giro di vite sulla stampa indipendente ha favorito il progressivo ritorno a metodi di propaganda neo-sovietica in linea con una lunga tradizione di manipolazioni e distorsioni della realtà.
Non è un caso che da qualche giorno, proprio nella Crimea occupata, le reti televisive ucraine Canale 5 e 1+1 siano state oscurate, sostituite da canali russi. La macchina ben oliata della disinformacija ha favorito la diffusione di notizie false come quella che dipinge i manifestanti del Maidan come fascisti e antisemiti, o quella secondo cui il nuovo governo ad interim avrebbe negato agli ucraini il diritto di parlare russo.
“L’Ucraina è in mano a estremisti e fascisti. Chiediamo aiuto ai fratelli russi perché ci vengano a liberare”. La rozzezza di certe manipolazioni farebbe sorridere se non fosse che la situazione in Crimea, che rischia di estendersi a tutto il paese, è davvero drammatica. La verruca sul naso della Russia – così Potemkin chiamava la Crimea – è tornata a fare male. Auguriamoci non sia il preludio a una Nuova Guerra Fredda che soffochi nel sangue le aspirazioni di libertà, pace e democrazia del popolo ucraino.
L’autore, Massimiliano Di Pasquale, è membro dell’AISU, Associazione Italiana di Studi Ucraini. Autore di “Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta” (Il Sirente). Lo scorso 5 Febbraio 2014 è stato relatore alla tavola rotonda ‘Ucraina Quo Vadis?’ organizzata dall’ISPI.
-
UCRAINA: Cosa sta succedendo a Kiev? Intervista a Max Di Pasquale
| East Journal | Sabato 22 febbraio 2014 | Pietro Rizzi |
 Cosa sta succedendo a Kyiv ed in Ucraina? Quali prospettive? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Di Pasquale, esperto di Ucraina, autore di Ucraina terra di confine e collaboratore di EastJournal. (altro…)
Cosa sta succedendo a Kyiv ed in Ucraina? Quali prospettive? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Di Pasquale, esperto di Ucraina, autore di Ucraina terra di confine e collaboratore di EastJournal. (altro…) -
Ucraina, nazisti o nazionalisti? Viaggio nell’arcipelago del radicalismo
| La Stampa | Sabato 22 febbraio 2014 | Anna Zafesova |
 A 55 anni dalla morte Stepan Bandera continua a spaccare il Paese. Per i russi è un ammiratore di Hitler che sta ispirando i manifestanti
A 55 anni dalla morte Stepan Bandera continua a spaccare il Paese. Per i russi è un ammiratore di Hitler che sta ispirando i manifestantiTra l’infinità di simboli e bandiere che sommergono il Maidan ogni tanto fa capolino il ritratto di un uomo dalla alta fronte stempiata, i tratti sottili e lo sguardo infuocato. Per molti è un volto sconosciuto, per altri un’icona, per altri ancora la prova che a muovere la protesta ucraina sono le forze più oscure della sua storia. 55 anni dopo la sua morte, avvelenato da uno spray al cianuro spruzzato da un agente del Kgb in piena Monaco, Stepan Bandera, leader dei nazionalisti ucraini, continua a spaccare in due il suo Paese. Per i russi, e per alcuni commentatori occidentali, la sua presenza in forma di ritratto è il segno che sul Maidan si consuma una vendetta storica contro la Russia, e che i militanti della piazza che oggi riesumano la sua immagine sono “nazisti”. (altro…)
-

Ucraina terra di confine: un libro per scoprire l’Europa sconosciuta
| Corso Italia News | Venerdì 21 febbraio 2014 | Simona Ciniglio |
 Gli eventi ucraini di questi giorni riempiono di apprensione noi e i numerosi cittadini ucraini residenti in Campania. La situazione è ancora critica, in attesa che il primo ministro Yanukovic, personaggio che si è dimostrato inaffidabile, accetti e dia prova di un reale accordo per riportare la calma.
Gli eventi ucraini di questi giorni riempiono di apprensione noi e i numerosi cittadini ucraini residenti in Campania. La situazione è ancora critica, in attesa che il primo ministro Yanukovic, personaggio che si è dimostrato inaffidabile, accetti e dia prova di un reale accordo per riportare la calma.
L’Ucraina, non dimentichiamolo, è il più grande Stato europeo per estensione (se si esclude la Russia), la cui identità – europea o asiatica – è sempre in discussione. Con quasi cinquanta milioni di abitanti, ricco di risorse anche naturali, l’Ucraina si trova geopoliticamente in una posizione delicatissima tra l’area di influenza europea e quella russa. (altro…) -

Ve la do io la vera Ucraina
| Il Messaggero | Lunedì 13 gennaio 2013 | Elisabetta Marsigli |
 Il fascino per una terra lontana può rimanere un sogno, ma per Massimiliano Di Pasquale si è trasformato in realtà. Fotogiornalista e scrittore freelance, Di Pasquale ha fatto dell’Ucraina una vera passione e, dopo aver scritto di politica internazionale e cultura su diversi quotidiani nazionali, nel 2007, grazie all’intervista con l’allora Presidente ucraino Viktor Yushchenko, inizia un approfondimento culturale e sociale del paese dei cosacchi.
Il fascino per una terra lontana può rimanere un sogno, ma per Massimiliano Di Pasquale si è trasformato in realtà. Fotogiornalista e scrittore freelance, Di Pasquale ha fatto dell’Ucraina una vera passione e, dopo aver scritto di politica internazionale e cultura su diversi quotidiani nazionali, nel 2007, grazie all’intervista con l’allora Presidente ucraino Viktor Yushchenko, inizia un approfondimento culturale e sociale del paese dei cosacchi.
(altro…) -
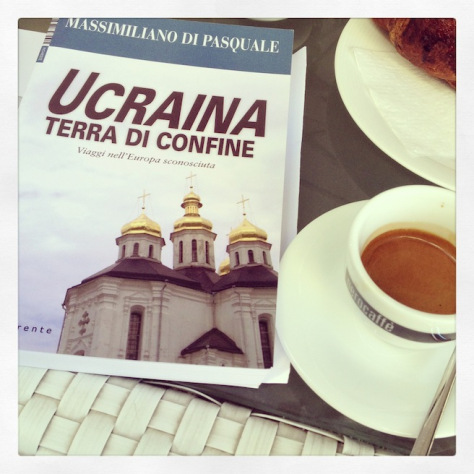
Colazione con Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista esperto di Ucraina
| Alibionline | Giovedì 12 dicembre 2013 | Saul Stucchi |
“Ukraïna tse Ukraïna!” L’Ucraina è Ucraina! Ricordate il simpatico spot che a metà degli anni Novanta reclamizzava il nuovo atlante geografico venduto a fascicoli settimanali con Il Corriere della Sera? Al cosmonauta atterrato in mezzo al suo pollaio, la contadina ucraina teneva una rapida lezione di geografia per aggiornarlo degli epocali cambiamenti avvenuti durante la sua missione nello spazio. “Ne sono successe di cose negli ultimi anni” diceva lo speaker. E non hanno smesso di succedere, vien da dire osservando (da lontano) quanto sta accadendo in queste settimane a Kiev, capitale dell’Ucraina. (altro…)
-
Prima delle badanti, c’era Hollywood – L’Ucraina segreta dai cosacchi alla Ceka
| La Stampa | Mercoledì 25 novembre 2013 | Anna Zafesova |
 Massimiliano Di Pasquale scrive il primo racconto in italiano di una terra vicina quanto sconosciuta: “Ucraina terra di confine” è un diario di viaggio che fa parlare i ricordi e le storie delle persone incontrate. (altro…)
Massimiliano Di Pasquale scrive il primo racconto in italiano di una terra vicina quanto sconosciuta: “Ucraina terra di confine” è un diario di viaggio che fa parlare i ricordi e le storie delle persone incontrate. (altro…) -

2012 — libri dell’anno, libri mancati, libri sbagliati, libri recuperati…
| Porto Franco | Venerdì 28 dicembre 2012 | Gianfranco Franchi |
Un franco 2012. Libri dell’anno:
- Umberto Roberto, “Roma Capta. Il Sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi”, Laterza. Un grande libro di storia, scritto per raccontare che l’eternità di Roma è terminata da un pezzo. È finito tutto nella metà del V secolo dopo Cristo: nel sangue e nella miseria. Roberto ha pizzicato uno dei veri rimossi della nostra cultura: l’ammissione della lontana morte di Roma, spogliata di tutto, tradita e abbandonata.
- Emanuele Trevi, “Qualcosa di scritto”, Ponte alle Grazie. Uno strano e seducente anfibio, metà tributo a Pasolini, metà memoir, metà romanzo iniziatico, metà grande saggio su “Petrolio”. Un libro veramente potente.
- Tommaso Giagni, “L’estraneo”, Einaudi. Un esordio tosto e promettente: un libro intriso di Zeitgeist; una leale rappresentazione del degrado e del collasso della civiltà romana moderna, a uno sbuffo dagli anni Zero.
- Jean Echenoz, “Lampi”, Adelphi. Grande opera d’arte. Biografia lirica e ispirata del misconosciuto e talentuoso Nikola Tesla, spirito slavo e nobile, generoso e mezzo matto. Un vero libro adelphi.
- Jáchym Topol, “L’officina del diavolo”, Zandonai. Grottesco, cinico, originale: romanzo del borgo di Terezín, del martirio della civiltà e della verità per mano dei totalitarismi, della speculazione sui genocidi.
- Colette, “Prigioni e paradisi”, Del Vecchio. Insperata, riuscita prima edizione italiana di questo libro di frammenti e prose brevi della scrittrice francese. Una lezione di stile, di letterarietà e di sensualità.
- Vasile Ernu, “Gli ultimi eretici dell’impero”, Hacca. Fascinosa integrazione dell’opera prima dello scrittore e filosofo rumeno, “Nato in Urss”, è una meditazione sul socialismo sovietico, sui gulag, sulla libertà d’espressione, sul futuro della civiltà. Molto coraggioso.
- Massimiliano Di Pasquale, “Ucraina terra di frontiera”, Il Sirente. È il libro di una vita: un intelligente e consapevole atto d’amore di un letterato italiano appassionato di cultura ucraina – vero ponte pop tra l’Italia e l’Ucraina. Forse l’unico.
- Diego Zandel, “Essere Bob Lang”, Hacca. Spiazzante romanzo metaletterario dello scrittore fiumano-romano Diego Zandel, filelleno, lettore forte, erede di Fulvio Tomizza. Divertissement molto snob.
- Watt Magazine, numero zero.cinque. Perché è forse la massima espressione dell’arte di Maurizio Ceccato: prima di essere libro-rivista, raccolta di racconti illustrata o raccolta di illustrazioni raccontate, Watt è un Ceccato. E Ceccato è il massimo.
Libro più sbagliato dell’anno: Tommaso Pincio, “Pulp Roma”, Il Saggiatore. Il primo libro completamente sbagliato di Tommaso Pincio: improbabile, marginale, male assemblato: indegno di lui. Un errore inatteso. È proprio brutto.
Capolavoro mancato: Emanuel Carrère, “Limonov”, Adelphi. Biografia romanzata di uno scrittore che aveva già romanzato la sua vita in tutti i suoi (molti) libri, sin dagli esordi, poteva essere una grande satira di Limonov, e dei Limonov, e una potente lezione di storia russa contemporanea, con incursioni nelle orgogliose ferite dei Balcani, à la Babsi Jones: invece Carrère si è preso molto sul serio, forte forse della consapevolezza che Limonov, in Europa, è veramente sconosciuto. E così ha sbagliato libro. Questo è un buon libro, ma è per i tanti neofiti di Limonov. Per tutti gli altri, è un discreto bignami, con qualche improbabile deriva ombelicale carrèra.
Letture rinviate: 1. Filippo Tuena, “Stranieri alla terra” [Nutrimenti, 2012]. La ragione è che punto all’operaomnia, entro due anni. 2. John Cheever, “Racconti” [Feltrinelli, 2012]. Stesso discorso, ma vorrei comunque leggerlo prima in lingua originale. 3. John Edward Williams, “Stoner” [Fazi, 2012]. Immagino possa piacermi molto, ma non è il periodo giusto. Magari tra qualche anno.
Sito letterario dell’anno: Flanerì. http://www.flaneri.com/ – sempre intelligente, particolarmente ordinato, piacevolmente frontale, piuttosto equilibrato: praticamente uno dei pochi siti letterari italiani credibili, in assoluto. Onestamente, una delle pochissime nuove proposte degne di nota, in quest’ultimo triennio caotico, fiacco e molto cialtrone. Tifo Flanerì.
Altre cose franche. Recuperi [italiani] dell’anno. 1. Fulvio Tomizza, “Il sogno dalmata”, Mondadori, 2001. 2. Babsi Jones, “Sappiano le mie parole di sangue”, Rizzoli, 2007. 3. Fulvio Tomizza, “Materada”, Mondadori, 1960. 4. Tommaso Pincio, “Hotel a zero stelle”, Laterza, 2011. 5. Ornela Vorpsi, “Il paese dove non si muore mai”, Einaudi, 2005.
Recuperi [stranieri] dell’anno. 1. Patrick Leigh Fermor, “Mani”, Adelphi, 2006. 2. Dimitri Obolensky, “Il commonwealth bizantino”, Laterza, 1974. 3. Dragan Velikić, “Via Pola”, Zandonai, 2009. 4. Robert Mantran [a cura di], “Storia dell’impero ottomano”, Argo, 2000. 5. Agostino Pertusi [a cura di], “La caduta di Costantinopoli”, Fondazione Valla, 1976. 6. Nicholas Valentine Riasanovsky, “Storia della Russia”, Bompiani, 7. David Foster Wallace, “Il tennis come esperienza religiosa”, oggi in Einaudi, 2012.
Lettura critica fondamentale, in assoluto: “Narratori degli Anni Zero” di Andrea Cortellessa, Ponte Sisto, 2012, 650 pagine. E via andare.
-
Ucraina terra di confine. Intervista a Massimiliano Di Pasquale
| Welfare Cremona Network | Lunedì 25 giugno 2012 | Alessandra Boga |
Poco l’Europa occidentale sa dell’Ucraina, questa repubblica dell’ex URSS, che tra l’altro è il più grande Paese d’Europa per estensione geografica; ma Massimiliano Di Pasquale, classe 1969, fotoreporter e scrittore pesarese, nel suo “diario di viaggio”Ucraina. Terra di confine, edito da Il Sirente, ci dà un quadro complessivo e affascinante di questa terra ancora prigioniera ai nostri occhi del grigiore post-sovietico, e che tuttavia è ricca di vita, storia e di cultura proprie, che il comunismo ha cercato di assimilare e soffocare.
Allora, Massimiliano, partiamo dal titolo del tuo libro: perché la definizione dell’Ucraina come “terra di confine”?
Premesso che non è mai facile scegliere il titolo di un libro, visto che dovrebbe sintetizzare i tanti temi trattati al suo interno, ritengo che Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta enfatizzi due concetti che mi stanno particolarmente a cuore perché costituiscono un filo rosso che unisce tutti i capitoli. Il primo è l’idea che l’Ucraina è tuttora una terra di confine dato che al suo interno si incontrano/scontrano culture diverse e visioni geopolitiche contrastanti. L’eterno oscillare tra Est e Ovest, tra Russia e UE, che ha caratterizzato storicamente questa terra e continua a caratterizzarla ancora oggi dice di un paese sicuramente europeo, perché europee sono le sue radici, ma di “confine”. Il secondo è che nonostante l’Ucraina sia il paese più esteso dell’Europa molte persone ancora la confondono con la Russia o la associano a una stereotipata immagine di grigiore post-sovietico. Il libro nasce anche per combattere questi stereotipi.
Che chiesa è quella bellissima dalle cupole dorate ritratta sulla copertina del libro?
È la Chiesa di Santa Caterina di Chernihiv, città a circa 100 km da Kyiv. Fu fondata da un colonnello cosacco nel 18° secolo in segno di gratitudine per la vittoria conseguita contro i Turchi. Sorge sotto il Val, la cittadella che costituiva il nucleo centrale dell’antica Chernihiv. Le sue cinque cupole dorate, che luccicano in lontananza, danno il benvenuto a chi arriva qui venendo dalla capitale.
Cos’è rimasto dell’epoca comunista in Ucraina, e puoi dirci se gli ucraini si sentono vicini all’Occidente?
Sono tante le eredità dell’epoca comunista che gravano tuttora sull’Ucraina. Alcune di carattere puramente estetico, come gli edifici in stile costruttivista o le statue di Lenin presenti nell’Ucraina centrale e orientale, altre più profonde, di carattere antropologico che continuano a permeare la mentalità di molte persone, rappresentando a tutti gli effetti un freno all’emancipazione e alla modernizzazione del paese. Ciò detto, la coscienza europea e il senso di appartenenza al mondo occidentale si stanno sempre più diffondendo nelle città dell’Ovest di ascendenza polacco-lituana-asburgica e più in generale, un po’ in tutto il paese, tra le nuove generazioni.
Una delle città più caratteristiche dell’Ucraina è Leopoli: perché è cosi importante?
Leopoli è forse l’unica città in cui la transizione dall’Ucraina post-sovietica all’Ucraina europea è già avvenuta. Prova ne è l’efficienza dei servizi che non ha eguali nel resto del paese. Ovviamente ci sono delle precise motivazioni di ordine storico-culturale che spiegano questa ‘eccezionale diversità’. In primis la legacypolacco-asburgica e l’impermeabilità o quasi – impermeabilità della Galizia al processo di russificazione-sovietizzazione, che ha interessato questa regione nel secondo dopoguerra. Come scrivo in un passo del libro “chi si avventurasse a Lviv alla ricerca di scampoli di Unione Sovietica rimarrebbe profondamente deluso”.
Quali culture e popolazioni hanno convissuto nei secoli in Ucraina?
Davvero tante: armeni, greci, russi, serbi, tatari, ebrei… Storicamente si parte dagli Sciti, popolazione nomade precristiana della steppa tra il Don e il Dnipro fino ad arrivare alle comunità italiane di Kerch in Crimea nell’800. Leopoli, Odessa e Chernivtsi sono forse le città più rappresentative di questo eccezionale melting pot. Proprio a Chernivtsi, dove tra l’altro nacquero gli scrittori Gregor Von Rezzori e Paul Celan, ancora oggi convivono ben sessantacinque diverse nazionalità!
Quali sono i personaggi storici e della cultura più rappresentativi dell’Ucraina e di cui anche l’Europa è debitrice?
L’Ucraina è un paese complesso e stratificato con una grande tradizione culturale per cui non è facile rispondere a questa domanda. Se limitiamo il discorso solo agli intellettuali di lingua e cultura ucraina farei tre nomi su tutti: Taras Shevchenko, Ivan Franko e Lesya Ukrayinka. Ciò che li accomuna, pur nella diversità dei percorsi, è l’avere fatto conoscere attraverso la letteratura il loro paese, cercando di ancorarlo alle avanguardie culturali dell’epoca. Taras Shevchenko, poeta ed eroe nazionale, è unanimemente considerato uno degli esponenti più autorevoli del romanticismo europeo.
Cos’è stata la tragedia dell’Holodomor?
Nel terribile biennio 1932-1933 l’Ucraina – come testimoniano anche i dispacci inviati a Roma da Sergio Gradenigo, console italiano nell’allora capitale Kharkiv – fu colpita da una ‘carestia artificiale’ pianificata dal regime stalinista per collettivizzare le campagne sterminando i kulaki (piccoli proprietari terrieri) e l’intellighenzia nazionale. Il termine ucraino Holodomor, che significa morte per fame, è composto di due parole holod – carestia, fame – e moryty – uccidere. Questo vero e proprio genocidio, occultato anche grazie alla complicità dell’Occidente, venne alla luce solo cinquant’anni più tardi per la pressante opera di sensibilizzazione della Diaspora ucraina. Nel 1986, con l’uscita del libro The Harvest of Sorrow dello storico americano Robert Conquest, il grande pubblico e le cerchie governative occidentali vennero a conoscenza di questa terribile tragedia.
In Ucraina è avvenuto un altro sterminio sconosciuto, il “genocidio dei Tatari”: di che cosa si tratta?
Quella dei tatari, così come quella che aveva interessato due anni prima, nel 1942, la comunità italiana di Kerch, è una delle tante tragedie sconosciute dello stalinismo. Con il decreto n. GKO5859 firmato da Josif Stalin l’11 maggio 1944 – un documento riservato venuto alla luce recentemente dall’archivio del KGB – il dittatore georgiano dà inizio alla seconda fase della pulizia etnica della Crimea. I metodi usati sono più o meno gli stessi adottati undici anni prima nei confronti dei contadini ucraini durante la Grande Carestia del ’32-’33. L’unica differenza rispetto al Holodomor è la rapidità con cui si consuma questa seconda tragedia. Nel corso di un solo giorno, il 18 maggio 1944, senza alcun preavviso, donne, bambini e anziani vengono gettati fuori dalle loro dimore, caricati su dei camion e condotti alla più vicina stazione ferroviaria. Accatastati come bestie dentro vagoni merci, sono spediti in Asia Centrale, sugli Urali e nelle aree più remote dell’URSS. Quasi la metà dei deportati – si parla di cifre intorno al 46% – non giungerà mai a destinazione. Falcidiati da fame, sete e malattie, moriranno lungo il tragitto.
Com’è nata la Rivoluzione Arancione?
La Rivoluzione Arancione nasce come risposta ai brogli elettorali nelle elezioni presidenziali del novembre 2004, in cui si confrontavano il candidato dell’opposizione Viktor Yushchenko e l’attuale presidente Viktor Yanukovych, sponsorizzato dal Cremlino e dal presidente uscente Leonid Kuchma. Sul Maidan Nezalezhnosti di Kyiv una popolazione composita, fatta di studenti, professionisti, preti uniati e ortodossi, manifestava pacificamente per la democrazia chiedendo la ripetizione del voto. Il 3 dicembre la Corte Suprema Ucraina accolse la tesi del candidato dell’opposizione Yushchenko e annullò la consultazione del 21 novembre ordinando la ripetizione del ballottaggio per il 26 dicembre. Yushchenko vinse, fu eletto Presidente e si aprì una nuova stagione carica di aspettative in parte purtroppo disattese.
Perché a tuo avviso la stagione arancione non ha prodotto i cambiamenti che la gente si aspettava?
Le motivazioni alla base del parziale fallimento della Rivoluzione Arancione, dico parziale perché comunque quella stagione è stata caratterizzata da libertà di stampa, pluralismo ed elezioni trasparenti – è ovviamente oggetto di dispute e studi tra gli storici.
Sicuramente Viktor Yushchenko si è rivelato un presidente debole, che non è riuscito a imprimere il necessario cambio di marcia per rigenerare moralmente ed economicamente il Paese.
Dovessi evidenziare tre cause su tutte citerei l’accesa rivalità con l’ex alleata Yulia Tymoshenko, il perimetro costituzionale, voluto dall’ex Presidente Kuchma come conditio sine qua non per la ripetizione del voto, che ha limitato fortemente i poteri di Yushchenko una volta in carica e last but not least l’incapacità del Presidente di scegliersi consiglieri leali e capaci. -

I luoghi di Schulz
| L’indice di libri del mese | Sabato 1 dicembre 2012 | Donatella Sasso |
 La passione per un luogo, per una lingua, per un’atmosfera sospesa fra sapori e colori nasce come un’amicizia e forse anche come un amore. Un incontro propizio, che non si esaurisce nello spazio di qualche suggestione, ma che impone a gran voce di essere approfondito, investigato, compreso. Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista e scrittore freelance, viaggia per la prima volta in Ucraina nel 2004. È la curiosità a chiamarlo, ma sarà solo l’inizio di numerose altre spedizioni in terra di confine, perché Ucraina significa proprio questo: confine. Terra di mezzo e di conquista, contesa tra Russia, regno di Polonia, granducato di Lituania, imperi asburgico e sovietico, è spesso stata confusa, attribuita ad altri mondi e ad altri destini nazionali. Che Gogol’ e Bulgakov siano originari di li non è dato universalmente acquisito, che in Ucraina non si parli solo il russo, ma anche l’ucraino, idioma autonomo più simile alle lingue slave del Sud che al russo, non sempre si rammenta.
La passione per un luogo, per una lingua, per un’atmosfera sospesa fra sapori e colori nasce come un’amicizia e forse anche come un amore. Un incontro propizio, che non si esaurisce nello spazio di qualche suggestione, ma che impone a gran voce di essere approfondito, investigato, compreso. Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista e scrittore freelance, viaggia per la prima volta in Ucraina nel 2004. È la curiosità a chiamarlo, ma sarà solo l’inizio di numerose altre spedizioni in terra di confine, perché Ucraina significa proprio questo: confine. Terra di mezzo e di conquista, contesa tra Russia, regno di Polonia, granducato di Lituania, imperi asburgico e sovietico, è spesso stata confusa, attribuita ad altri mondi e ad altri destini nazionali. Che Gogol’ e Bulgakov siano originari di li non è dato universalmente acquisito, che in Ucraina non si parli solo il russo, ma anche l’ucraino, idioma autonomo più simile alle lingue slave del Sud che al russo, non sempre si rammenta.Ed è proprio su questo equivoco di indeterminatezza che si sono giocate, in passato come oggi, rivendicazioni di autonomia e pretese egemoniche provenienti da lontano. La rivoluzione arancione del 2004 con la vittoria di Yushchenko aveva indotto a pensare a una democratizzazione del paese e a un avvicinamento all’Europa e alle sue istituzioni. La Speranza è durata poco, il presidente è stato soppiantato da Yanukovych, alleato della Russia di Putin è grande sconfitto nel 2004, che alle elezioni del 2010 ha conquistato il potere consumando le proprie rivincite. In primo luogo con il processo per abuso di potere e la condanna all’ex premier Yulia Tymoshenko, un processo definito a livello locale e internazionale “politico”, privo di garanzie e con gravi violazioni dei diritti umani. Di Pasquale tratta anche di questo, ma non offre ne un saggio di storia, ne una riflessione politica. Le sue sono impressioni di viaggio, ricerche e scoperte che si scambiano cronologicamente l’ordine di apparizione, incontri fugaci e lunghe interviste con scrittori, giornalisti e imprenditori, notti in hotel fatiscenti, ma fascinosi, viaggi in marshrutky, minibus per il trasporto pubblico, lenti e obsoleti. Ogni capitolo è dedicato a una città, da ovest verso est e ritorno. Ne esce il ritratto di un paese ammaliante: alle architetture mitteleuropee di Leopoli si alternano le grigie periferie nel perfetto stile del realismo socialista, Bruno Schulz e Vasily Grossman mostrano i luoghi delle loro scritture, le note gastronomiche sanno di Oriente, le cupole delle chiese ortodosse sono dorate.
Come in altri paesi dell’ex Unione Sovietica, anche qui le contrapposizioni politiche e culturali si muovono spesso sui recupero o sull’occultamento di avvenimenti storici, miti fondatori ed eroi contesi. E l’Ucraina gronda storia da ogni zolla di terra. Di Pasquale rievoca i movimenti autonomisti dell’Ottocento, la tragedia dello Holodomor, la carestia indotta da Stalin negli anni trenta, le occupazioni nazista e sovietica, la Shoah, Chernobyl. L’Ucraina è tutto questo: dolore, poteri forti concentrati in poche mani, povertà diffusa, ma soprattutto terra da scoprire, estremo lembo d’Europa che chiede di essere riconosciuto.
-

“Ucraina, Terra di Confine. Viaggi nell’Europa Sconosciuta” di Massimiliano Di Pasquale
| Ucraina Cisalpina (con l’accento sulla i) | Mercoledì, 24 ottobre 2012 | Gabriele Papalia |
 Ucraina terra di confine o Ucraine terre di confine?
Ucraina terra di confine o Ucraine terre di confine? Questo è ciò che mi è venuto in mente finendo il bel libro di Massimiliano Di Pasquale.
Un libro che è resoconto di viaggio, dichiarazione di amore e di speranza verso il paese “maledetto dalla steppa”: un’opera che svela realtà, vite e destini inediti all’interno di quel paese conosciuto ad occidente come Ucraina.
Chi pensa all’Ucraina in genere ha in mente la Russia, facendo un paragone inesatto e fuorviante ma inevitabile, dato che in questo modo il paese ci è sempre stato rappresentato dalla televisione generalista e dall’istruzione obbligatoria.
E questo ha fatto apparire l’Ucraina come un eterno stato periferico, una terra “appartenente al confine” russo, una porzione geografica senz’anima con qualche città famosa perché orbitante intorno al mondo dei grandi russi.Ma che paese è l’Ucraina?
Ce lo racconta Di Pasquale con i suoi appunti tracciati nel corso di questi anni a bordo di mashrutke sgangherate (i mitici pulmini che fanno da taxi nei paesi dell’ex URSS), treni che per l’atmosfera ricordano tempi andati (solo per noi occidentali) con gente accogliente e talora imprevedibile, in hotel dal gusto mittleuropeo dell’Ucraina occidentale fino agli alberghi più insperati e “squallidamente sublimi” diDnipropetrovsk e qualche altra città che puzza di carbone e acciaio.
Per chi ha visitato questi posti – ma anche per chi non lo ha mai fatto – sembrerà di entrare nel vivo della scena di questi racconti di viaggio.Dopo la lettura di “Ucraina Terra di Confine”, a molti verrà voglia di visitare questo paese; i profani si stupiranno di quanta cultura, civiltà, bellezza e profondità sia parte integrante del popolo ucraino. Ma anche di quante tragedie e di quanti destini di vita siano stati dimenticati, opportunamente celati all’Europa e talora anche all’Ucraina stessa da parte dell’ingombrante e parziale propaganda russa.
Ucraina terra di confini: soprattutto mentali
L’Ucraina è Europa ma per alcuni è ancora troppo lontana, troppo inesplorata, troppo “ma una volta questa parte del mondo apparteneva all’Unione Sovietica”: geograficamente conquistata con violenza dai russi – lo si dovrebbe ammettere senza difficoltà al giorno d’oggi – questo confine mentale di equiparare Russi e Ucraina, non è ancora stato superato.
E allora leggendo e meditando intorno a questo paese, ci si pone delle domande anche sulla propria identità: che cos’è Europa, dov’è il confine? Dove inizia e quando finisce? Che cos’è che determina il territorio comune tra noi e l’Ucraina?
L’autore implicitamente ci dà la risposta portando alla conoscenza, per chi è digiuno di questi luoghi, che un tempo Lviv fu anche Leopoli e Lemberg sotto il dominio asburgico, e italiani e armeni erano soliti visitare e abitare queste terre; che città comeLutsk e Kamyanets Podilsky godevano del Diritto di Magdeburgo ma anche della benedizione del Pontefice di Roma e per secoli territorio conteso tra regnanti polacchi all’ultima frontiera col nemico ottomano.
Permangono però molte cose in Ucraina che non appaiono “europee” e hanno più il gusto mistico estremista che, in alcuni casi, contraddistingue certi modi di pensare slavo orientali: dal movimento di Asgarda, efficacemente riportato dall’autore, all’uso inutilmente autoritario delle istituzioni governative e dei portinai degli alberghi ai proclami continui che ogni cosa è “nasha” (nostra): nasha piva (nostra birra), nasha Ucraina, nasha stranà (nostro paese).
E però a Lviv non si respira l’aria autoritaria di Mosca ma nemmeno a Donetsk.
Donetsk non si sente Russia e questo è ribadito da Di Pasquale, sebbene i legami tra questa città del Donbas e la Federazione Russa siano tradizionalmente e culturalmente molto stretti.
Ucraina come confine tra due realtà ed entità culturali (una occidentale, mittleuropea e l’altra russa e ortodossa): è un paese ibrido, come un colore mischiato che parte da colori puri e si dissolve in sfumature del tutto particolari.
A questo è dovuto l’innegabile fascino di questo paese: di non essere monotono e predeterminato.
Si rischia il manicomio ad affrontare tematiche identitarie su questo paese ma senz’altro si può dire che Massimiliano abbia colto il punto essenziale della questione identitaria di questo popolo:il popolo ucraino è “contaminato” nel bene e nel male
Ucraina terra invasa, terra di convivenza pacifica ma anche di massacri, terra liberata e da liberare, terra inquinata dal nucleare e dalle fabbriche del suo lato orientale.
Una contaminazione chiara e resa evidente nelle pagine del libro attraverso diversi aspetti su cui l’autore si focalizza: la letteratura, l’architettura e le etnie che in questa terra abitano, hanno abitato il suolo ucraino e l’hanno indelebilmente condizionato.
Ebrei, tedeschi, armeni, ucraini, polacchi, ungheresi, sciti, russi, tatari, genovesi, caucasici: tutti a loro modo hanno contribuito alla formazione di quello che è il più grande paese di Europa per estensione geografica.
Di Pasquale rende onore alle vittime del disastro di Chornobyl, l’ultima (e maledetta) contaminazione di questa terra, il lascito più terribile che l’URSS abbia mai potuto trasmetterci.Creazione che risveglia dall’oblio e che ci avvicina a un popolo.
Chi è digiuno della storia di questo paese troverà modo di comprendere meglio il complessissimo mosaico di cui si compone questa terra.
Il libro di Di Pasquale è anche un modo per non dimenticare le tragedie del popolo ucraino (e lo fa sapientemente, in modo da non incorrere nel rischio di raffigurare l’Ucraina come un paese vittimista che si piange sempre addosso e parla solo delle sue disgrazie).
Tra le tragedie del passato di cui si parla – e che è comunque d’obbligo citarle – non c’è solamente quella del popolo ucraino (holodomor) e del popolo ebraico ma anche quella dei tatari e degli italiani di Crimea avvenuta ai tempi di Stalin.
Anche la Crimea, infatti, è Ucraina e confine dell’Europa soprattutto per un motivo: si possono trattare le tematiche della deportazione dei tatari e degli italiani di Crimea dal momento in cui la penisola è controllata e gestita da Kiev e non da Mosca.
Difficilmente sarebbero state possibili delle indagini così approfondite se la Crimea al giorno d’oggi fosse appartenuta ai russi (a loro è dovuta la conquista di questa penisola, un tempo appartenuta ai Khan di Crimea), assai poco inclini ai mea culpa.
Viene riportato anche come la penisola resta contesa tra una diaspora riappropriatasi della sua patria e una parte di Russia di stampo bellicista che la rivorrebbe territorio coloniale panrusso (nasha).
La presenza del popolo ucraino e la proprietà odierna della penisola a Kiev, fortunatamente, non permette la realizzazione di questa scemenza.Un omaggio all’ucrainicità
Di Pasquale non nasconde le sue passioni nella narrazione: la giusta attenzione dedicata alle belle ragazze del luogo, il suo interesse per il folclore e i costumi della gente locale, lo strano gusto estetico – da me condiviso – per le orrorifiche architetture sovietiche di molte città.
Con la sua predilezione per il mondo della letteratura poi, viene resa giustizia a poeti ed intellettuali nazionali come Ivan Franko, Anna Ahmatova, Lesya Ukrayinka, Taras Shevchenko e altri autori importanti ma a noi poco conosciuti (uno su tutti l’ebreo Bruno Schulz).
Vengono esaminati in modo del tutto particolare i luoghi sacri dell’ortodossia come ilavra di Pochayiv e Kyiv (Kiev) e a queste tematiche impegnate ci sono sempre degli agevoli intermezzi in cui l’autore fa le sue considerazioni, suda, si irrita per i prezzi esagerati dei taxi e contratta o si riposa assaporando i gustosi ed eccellenti cibi ucraini, tatari e georgiani.
Massimiliano Di Pasquale ha reso omaggio e onore, con il suo libro, al popolo ucraino ma anche a noi italiani: agli ucraini ha dato una carta in mano per essere capiti e rispettati, ad essere considerati come un popolo di una nazione a tutti gli effetti, con una loro storia, una loro lingua e una loro peculiare visione del mondo distinta dai vicini di casa (siano essi russi, polacchi o rumeni).
Così poco si è voluto far sapere di questa parte del mondo in cui è l’Ucraina che ogni pubblicazione divulgativa, per la nostra società, è come una manna dal cielo per tutti noi.
Agli italiani, invece, con questa pubblicazione viene data la possibilità di uscire dai soliti luoghi comuni che su questo paese abbondano e sono sempre gli stessi (inutile elencarli, il lettore gli ha già nella sua testa).
Consiglio a tutti questa lettura per comprendere meglio l’Ucraina, un paese che ha grandissima importanza per l’Europa tutta: dal punto di vista culturale nonché geopolitico (e quest’ultimo punto è assai chiarito da Di Pasquale in alcune sezioni dedicate alla politica ucraina contemporanea).
Quello che però mi affascina di più dell’opera del giornalista pesarese è come, in modo divertente, intelligente e appassionante, sia stato in grado di portare a far comprendere al lettore cosa significhi trovarsi in una terra irrisolta che è al tempo stesso un confine culturale e territoriale.
l’Ucraina contiene due anime ma vuole essere un unita e indipendente in una Europa rispettosa e che tuteli la sua caleidoscopica sovranità e identità nazionale: occidentale, cattolica, middeleuropea, slava orientale, ortodossa, ucrainofona, russofona, tatara, ungherese…..Mi fermo qui, sarebbe inutile continuare: a voi il piacere di assaporare la lettura di questo meraviglioso e indispensabile libro per una più agevole comprensione di questo grande e intricato paese che è l’Ucraina!
-
“Ucraina terra di confine”, il nuovo viaggio di Massimiliano Di Pasquale
| affaritaliani.it | Venerdì 14 settembre 2012 |
Leggendo Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta di Massimiliano Di Pasquale – scrive Oxana Pachlovska, docente di Ucrainistica all’Università “La Sapienza” di Roma – mi venivano sempre in mente certe figure storiche più o meno note degli instancabili viaggiatori italiani grazie ai quali noi abbiamo resoconti affascinanti dell’Est europeo o dell’Asia. In quei racconti di diversi Marco Polo degni di miglior fortuna ci potevano essere inesattezze o incompletezze, ma non mancava mai la volontà sincera di capire l’Altro, di instaurare con lui un dialogo.
Lo spirito che informa Di Pasquale – che fa propria la lezione di grandi narratori di viaggio come Chatwin, Kapuściński e Terzani – scrive ancora Pachlovska è quello di “un Marco Polo modernizzato che non manca mai di stupirci in questa sua opera disinvolta e accattivante, sempre lontana come non mai dalla banalità di tante guide turistiche che vanno per la maggiore”.
Il testo, intriso di rimandi letterari, di discorsi con personaggi noti e anonimi, di interviste e mere chiacchiere coi passanti, è un patchwork fascinoso capace di restituire la cifra ’sincopata’ di un paese poliedrico e dalle infinite sfaccettature. L’Ucraina raccontata dall’autore in un libro impreziosito da un inserto fotografico di ben 16 pagine curato dallo stesso Di Pasquale, è un paese nuovo e dinamico che tra accelerazione e fermate, stop and go, sta cercando, non senza difficoltà, di lasciarsi alle spalle la patina brumosa del post-totalitarismo per diventare soggetto della Storia.
-
Perché non si produce più petrolio
| Pino Buongiorno The Globalist | Venerdì 6 giugno 2008 | Pino Buongiorno |
 Flash dal mondo del petrolio. A San Paolo del Brasile la compagnia statale Petrobras annuncia di aver scoperto un immenso giacimento di greggio a 7mila metri di profondità, nel bacino Santos, con un potenziale, tutto da verificare, di 33 miliardi di barili. Tanto quanto basterebbe per fare entrare il Brasile nel club dei 10 maggiori esportatori di energia al mondo.
Flash dal mondo del petrolio. A San Paolo del Brasile la compagnia statale Petrobras annuncia di aver scoperto un immenso giacimento di greggio a 7mila metri di profondità, nel bacino Santos, con un potenziale, tutto da verificare, di 33 miliardi di barili. Tanto quanto basterebbe per fare entrare il Brasile nel club dei 10 maggiori esportatori di energia al mondo.
Cambiamo continente ed andiamo in Africa. A Pointe Noire, in Congo, l’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni firma un accordo con il governo di Brazzaville per ricavare oli non convenzionali dallo sfruttamento delle sabbie bituminose in un’area di 1790 chilometri quadrati.
Mentre in una sola settimana accade tutto questo, a Parigi l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) fa trapelare i primi risultati-shock di una ricerca su 400 fra i megadepositi mondiali di oro nero. Gli esperti dell’Aie sono allarmisti perché prevedono che la futura offerta di petrolio si ridurrà notevolmente. Contro gli attuali 87 milioni di barili consumati ogni giorno ne occorrerebbero 116 milioni nel 2030 per sostenere la domanda mondiale, spinta soprattutto dalla crescita di Cina e India. Invece l’invecchiamento progressivo dei pozzi e la diminuzione degli investimenti produrranno non più di 100 milioni di barili.
L’ultimo flash è scattato a Washington, dove i deputati e i senatori mettono quotidianamente sulla griglia i boss di “Big Oil” (i quattro colossi mondiali del petrolio). Li accusano di realizzare profitti smisurati a scapito degli automobilisti e di spendere troppo poco per lo sviluppo di nuovi giacimenti e soprattutto per la ricerca di fonti di energia alternative. Il più bersagliato è il presidente e amministratore delegato di Exxon Mobil, Rex Tillerson, che l’anno scorso ha fatto conquistare alla sua multinazionale un record mai raggiunto nella storia del capitalismo: 40,6 miliardi di utili. Per nulla intimorito dalla contemporanea ribellione dei discendenti della famiglia Rockefeller, fra i maggiori azionisti, che chiedono “una svolta verde”, Tillerson contrattacca e punta l’indice contro lo stesso George W. Bush perché è andato a Riad a chiedere al monarca saudita di pompare più greggio quando invece avrebbe dovuto fare di più per aumentare la produzione in America, in particolare, al largo delle coste della Florida e della California.
“Siamo al momento della verità soprattutto per le compagnie petrolifere” spiega a “Panorama” Steve LeVine, uno dei principali analisti del settore, autore del bestseller “The Oil and the Glory”, dedicato al “Grande gioco” del petrolio nel Caucaso, che sarà presto pubblicato anche in Italia. “C’è in questo momento una grande ansia e contemporaneamente un certo entusiasmo per scoprire pozzi finora inesplorati e anche risorse non convenzionali, come il petrolio pesante del bacino dell’Orinoco in Venezuela e le sabbie bituminose della provincia di Alberta, in Canada, e del Congo. Ma la corsa vera e propria non è ancora scattata. Inizierà solo quando le compagnie capiranno a quali nuovi condizioni dovranno trattare con i grandi paesi produttori di petrolio e di gas naturale, come l’Arabia Saudita, il Brasile e la Russia”.
Di certo, spiegano gli esperti, stiamo pagando i 20 anni di benzina a basso costo che hanno frenato, se non bloccato del tutto, l’esplorazione e l’estrazione del petrolio, perché non ne valeva la pena. Oggi gli alti prezzi (con il petrolio che potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile già quest’estate e i 200 dollari l’anno prossimo, secondo un recente rapporto di Goldman Sachs) dovrebbero spingere in senso contrario. Ma non è sempre così. E’ vero che l’Arabia Saudita ha promesso di investire 129 miliardi di dollari in progetti di espansione nei prossimi cinque anni, a cominciare dallo sfruttamento del campo petrolifero di Khurais, con l’obiettivo, già alla fine del prossimo anno, di aumentare la produzione quotidiana fino a 12 milioni di barili. Ma è altrettanto incontestabile il trend generale che si sta affermando fra i paesi produttori, i quali hanno il controllo del 90 per cento delle riserve mondiali: è il nazionalismo energetico. La Russia è in prima fila nel sostenere la necessità di mantenere alti i prezzi anche a costo di sacrificare le scoperte di nuovi giacimenti o di evitare il declino dei vecchi. E quando non sono le strategie politiche del Cremlino a dettare la politica energetica mondiale s’impongono le tensioni geopolitiche. Succede in Iraq, il secondo paese al mondo per riserve provate, dove le bande sunnite e sciite fanno a gara a bruciare i pozzi e a minare gli oleodotti. Accade in Iran, paralizzato dalle sanzioni internazionali per i progetti sulla bomba atomica. Per non parlare dalla Nigeria, infestata dalla guerriglia. Nel continente latino-americano è il Venezuela a non poter esprimere tutte le sue potenzialità a causa del “bolivarismo” di Hugo Chavez, che allontana i grandi investitori internazionali.
Quanto al restante 10 per cento gestito dalle ex sette sorelle, anche qui l’offerta non riesce a pareggiare la domanda. “L’esplorazione è certamente ripartita con grande vigore. Alcuni importanti successi sono già visibili in Africa e in Sud America” assicura a “Panorama” Claudio Descalzi, il vicedirettore generale della produzione di Eni. “Ma dobbiamo anche scontare la rigidità del sistema industriale: è limitata la disponibilità di piattaforme, di mezzi navali, di cantieri, di acciaierie e, non ultima, di personale specializzato”.
Tutto questo comporta un aumento vertiginoso dei costi per la costruzione dei nuovi impianti petroliferi e per la tecnologia necessaria finendo per ritardare quasi tutti i progetti più importanti., come Kashagan. Gli analisti del Cera, uno dei maggiori centri di ricerca del settore, hanno fatto un po’ di conti e sono arrivati alla conclusione che, “se nel 2000 un qualsiasi pezzo di equipaggiamento costava 100 dollari, oggi ne costa 210”.
In buona sostanza, almeno nel breve e nel medio periodo, la questione non è “la fine del petrolio”, ma la sua produzione largamente insufficiente. Per dirla con le parole di John Watson, uno dei capi di Chevron, “il problema dell’oro nero non è sotto la superficie, ma al di sopra”. -
Di là del Mar Caspio
Il petrolio è al centro dei principali intrighi planetari. Eldorado ed inferno, il Mar Caspio in questo senso è sempre apparso remoto, ostile, instabile.
 A lungo, ha tentato il mondo (inglesi, americani, russi, persino cinesi) con le sue grandi riserve petrolifere. Ma gli stranieri, bloccati dal sistema chiuso dell’Unione Sovietica, non vi poterono arrivare. Poi l’Unione Sovietica crollò, e nella regione iniziò una corsa frenetica su vasta scala. Insieme ai petrolieri, si accalcarono nel Caspio i rappresentanti dei principali Paesi del mondo in cerca di una quota dei trenta miliardi di barili di riserve petrolifere certe che erano in gioco, e iniziò una tesa battaglia geopolitica. I principali competitori erano Mosca e Washington – la prima cercando di mantenere il controllo sui suoi Stati satellite, la seconda intenta a far sloggiare la Russia a beneficio dell’Occidente.
A lungo, ha tentato il mondo (inglesi, americani, russi, persino cinesi) con le sue grandi riserve petrolifere. Ma gli stranieri, bloccati dal sistema chiuso dell’Unione Sovietica, non vi poterono arrivare. Poi l’Unione Sovietica crollò, e nella regione iniziò una corsa frenetica su vasta scala. Insieme ai petrolieri, si accalcarono nel Caspio i rappresentanti dei principali Paesi del mondo in cerca di una quota dei trenta miliardi di barili di riserve petrolifere certe che erano in gioco, e iniziò una tesa battaglia geopolitica. I principali competitori erano Mosca e Washington – la prima cercando di mantenere il controllo sui suoi Stati satellite, la seconda intenta a far sloggiare la Russia a beneficio dell’Occidente.
”Il petrolio e la gloria” è un libro di Steve LeVine (Editrice il Sirente, 20 Euro) in cui tutto ciò è ben raccontato. LeVine ha lavorato nella regione per il Wall Street Journal, il New York Times e il Newsweek, ed è ligio alla grande scuola americana del giornalismo d’investigazione. Egli svela le misteriose manovre dei giganti energetici mondiali per avere una parte nei ricchi giacimenti kazaki e azeri, mentre le superpotenze cercano di ottenere un punto di appoggio strategico nella regione e di ostacolarsi a vicenda. Al cuore della storia c’è la gara per costruire e gestire oleodotti che escano dall’isolata regione, la chiave per controllare il Caspio e il suo petrolio.
Il BTC, l’ oleodotto per il petrolio che fu costruito, il più lungo al mondo (1.750 chilometri, di cui oltre 300 attraverso la Georgia), è stato uno dei più grandi trionfi in politica estera di Washington. Molti i personaggi di questa saga caspiana. Per esempio, il “ competitor” James Giffen, un affarista americano che è stato anche il “faccendiere” a livello politico delle compagnie petrolifere ansiose di fare affari nel Caspio e l’intermediario per il presidente e i ministri del Kazakistan; o John Deuss, l’ostentato commerciante olandese di petrolio che vinse molto ma perse ancor di più; Heidar Aliyev, l’ ex capo del Kgb azero, diventato presidente, e spesso — secondo LeVine — frainteso: ma, secondo me, il suo è giudizio partigiano.
LeVine afferma che il presidente azero “trascese il suo passato di membro del Politburo sovietico e fu la mente direttiva di un progetto per allentare il controllo russo sulle sue ex colonie nella regione del Caspio”. In questa cornice trovano il loro posto furfanti, canaglie e avventurieri d’ ogni genere guidati dall’irresistibile richiamo di ricchezze incalcolabili e dalla possibile “ultima frontiera” dell’era dei combustibili fossili. Non mancano gli interrogativi geopolitici che ruotano attorno alla ricchezza petrolifera del Caspio, se la Russia possa essere un alleato affidabile e un partner commerciale dell’Occidente, e cosa significhi l’ingresso di Washington in questa regione caotica ma importante per la sua stabilità a lungo termine. -
Cina e Russia. Sfida aperta alle 5 sorelle
| La Stampa | Lunedì 19 novembre 2007 | Maurizio Molinari |
I giganti energetici di Pechino e Mosca pongono sfide molto diverse ma ugualmente serie ai concorrenti d’Occidente.
 È una delle barzellette più di moda ad Alma Aty, in Kazakhstan, a svelare cosa sta avvenendo sul mercato del greggio: «In città c’è una piccola delegazione cinese, sono diecimila». A raccontare l’aneddoto è Evan Feigenbaum, braccio destro del Segretario di Stato Condoleezza Rice sull’Asia Centrale e veterano delle guerre commerciali per il controllo delle risorse energetiche. Feigenbaum racconta la barzelletta al «Council on Foreign Relations» perché la ritiene veritiera: «Dal Mar Caspio all’Estremo Oriente i cinesi sono all’offensiva, costruiscono, acquistano, esplorano, investono e spendono una grande quantità di danaro e di risorse umane». Lo slancio della Repubblica popolare sul mercato energetico nasce dalla necessità di importare la metà del fabbisogno nazionale ed è riassunto dai nomi di tre giganti: China National Petroleum Corporation (Cnpc), China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) e Sinopec.
È una delle barzellette più di moda ad Alma Aty, in Kazakhstan, a svelare cosa sta avvenendo sul mercato del greggio: «In città c’è una piccola delegazione cinese, sono diecimila». A raccontare l’aneddoto è Evan Feigenbaum, braccio destro del Segretario di Stato Condoleezza Rice sull’Asia Centrale e veterano delle guerre commerciali per il controllo delle risorse energetiche. Feigenbaum racconta la barzelletta al «Council on Foreign Relations» perché la ritiene veritiera: «Dal Mar Caspio all’Estremo Oriente i cinesi sono all’offensiva, costruiscono, acquistano, esplorano, investono e spendono una grande quantità di danaro e di risorse umane». Lo slancio della Repubblica popolare sul mercato energetico nasce dalla necessità di importare la metà del fabbisogno nazionale ed è riassunto dai nomi di tre giganti: China National Petroleum Corporation (Cnpc), China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) e Sinopec.«Hanno ruoli e compiti diversi – spiega Edward Morse, analista di greggio di fama mondiale, in forza a Lehman Brothers – perché Cnpc è il gigante pubblico maggior produttore di carburante e Cnooc esplora i giacimenti off-shore in Cina mentre Sinopec va aggressivamente alla ricerca di nuovi mercati all’estero». Sijin Chang è l’analista di Eurasia Group che segue 24 ore su 24 le mosse dei tre colossi e assicura che «fanno una dura concorrenza alle grandi compagnie occidentali» per due ragioni. Primo: «Dispongono di soldi pubblici in grande quantità e non lesinano a spenderli». Secondo: «Su indicazione del governo sfruttano le aree di crisi per insediarsi». Gli esempi più lampanti vengono dal Sudan, dove Sinopec ha quasi un monopolio sulle estrazioni, e il Turkmenistan, dove sempre Sinopec ha siglato un contratto trentennale per la realizzazione di un mega oleodotto destinato a portare gas e carburante verso Oriente. «Pechino gioca duro nella grande partita degli oleodotti – assicura Steve LeVine, giornalista del Wall Street Journal autore del libro «The Oil and the Glory» – punta a siglare in Kazakhstan un contratto simile a quello turkmeno, per alimentarsi via terra senza dover passare per la Russia o per il Golfo Persico».
Ma non è tutto. Robin West, presidente di PFC Energy Inc. e fra i più ascoltati esperti di energia in America, spiega che «la forza dei cinesi è nel fatto che hanno manager aggressivi, gestiscono le aziende pubbliche come se fossero private e sono in grado di sfruttare a loro vantaggio le regole della concorrenza meglio di molte compagnie occidentali». Proprio a questo metodo «aggressivo e competitivo» West attribuisce il successo di PetroChina, di proprietà statale, che toccando un valore di mercato di un trilione di dollari ha scavalcato la rivale americana ExxonMobil – ferma a 488 miliardi di dollari – diventando questo mese la prima azienda del mondo per capitale azionario. «La sfida cinese alle Cinque Sorelle – aggiunge West riferendosi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali – è molto simile a quelle che si preparano in India e Brasile, giocano alle nostre stesse regole ed hanno ottimi manager ma con più denaro sul piatto».
Se questo avviene è anche perché le Cinque Sorelle – ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Chevron e ConocoPhillips – gestiscono diversamente i profitti: un recente studio del Baker Institute della Rice University attesta che spendono sempre di meno in esplorazioni, cedendo terreno ai rivali di altre nazioni che «sono dunque meglio posizionati per lo sfruttamento dei nuovi giacimenti». I monopoli non-occidentali «rappresentano i titolari dei primi dieci giacimenti del mondo mentre ExxonMobil, BP, Chevron, Royal Dutch e Shell sono rispettivamente al 14°, 17°, 19° e 25° posto» spiega Amy Myers Jaffe, autore del rapporto del Baker Institute. «Se le Cinque Sorelle spendono meno per l’esplorazione – osserva Morse – è perché per loro oramai la finanza conta più dell’estrazione e gli azionisti più dei trivellatori, destinano le risorse ad operazioni di mercato tese a rafforzare profitti più che a rischiare capitali in nuove aree».
Quando si dice «monopoli» Morse, West, LeVine e Jaffe pensano subito alla Russia di Vladimir Putin. «La sfida russa è diversa da quella cinese perché non è di mercato bensì si basa sulla gestione quasi monopolistica delle immense risorse nazionali» spiega West, secondo cui «l’unica maniera per rispondere è venire a patti, cedere quote di mercato internazionale per averne in cambio dentro la Russia». Alexander Kliment è l’analista russo di punta di Eurasia Group e legge così la mappa energetica: «Rosneft è probabilmente la più grande azienda petrolifera del mondo così come Gazprom ha pochi rivali sul gas, entrambe sono emanazione del potere politico e tengono sotto controllo le risorse nazionali». Mentre l’asso nella manica del Cremlino «è Lukoil»: sulla carta privata ma in realtà sotto il controllo di Putin, ha il compito di «esplorare nuovi mercati» insediandosi «lì dove l’Occidente non vuole o non può», a cominciare dall’Iran di Mahmud Ahmadinejad.
«Ma chi dovesse pensare che Lukoil si fermerà alle zone di crisi sbaglia – aggiunge Carter Page, responsabile dell’Energia per Merrill Lynch – perché la loro ambizione è portare la concorrenza sui mercati nordamericano ed europeo, come già sta avvenendo». Basta contare i distributori Lukoil a New York per accorgersene. Se l’aggressività di cinesi e russi è il tema del giorno per gli analisti petroliferi americani è anche vero che nessuno vede in questi nuovi giganti dei reali concorrenti sul piano della tecnologia. «Su innovazione e sviluppo né i russi né i cinesi sono in grado di sfidare le Cinque Sorelle – concordano Morse e West – la tecnologia resta il loro tallone d’Achille». Quali che siano le prossime puntate della sfida energetica Carter Page ha pochi dubbi su quanto sta avvenendo: «È l’energia il vero gioco del potere mondiale». -
Dal Caucaso all’Asia centrale, gas e petrolio nel «Grande Gioco»
| Le Monde Diplomatique | Giugno 2007 | Régis Genté (*) |
Il vertice di metà maggio tra l’Unione europea e la Russia si è arenato in particolare sulla questione della cooperazione energetica: l’Unione, che importa dalla Russia il quarto del proprio consumo di petrolio e di gas, si preoccupa dell’accresciuto potere di Mosca in questo campo. L’accordo concluso, il 12 maggio, dal presidente russo Vladimir Putin con i suoi omologhi turkmeno e kazako, conferma un rovesciamento di tendenza: a lungo messo sulla difensiva dalla politica di aggiramento degli oleodotti e dei gasdotti, imposta dalle grandi potenze, Mosca ha ripreso l’offensiva.
 Il nuovo «Grande Gioco» ha raggiunto il culmine. Con in più, questa volta, al centro del gioco, il petrolio e il gas. Ma la domanda di idrocarburi non spiega da sola la battaglia tra le grandi potenze che intendono impossessarsi dei giacimenti delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale e del Caucaso, sfuggite al dominio di Mosca con il crollo dell’Urss nel 1991. L’oro nero e l’oro grigio sono anche lo strumento di una lotta di influenza in vista del controllo del centro del continente eurasiatico. Per interposte major petrolifere, gli oleodotti sono le lunghe corde che consentono alle grandi potenze di ancorare al proprio sistema geostrategico i nuovi otto stati indipendenti (Nei) della regione (1). Nel XIX secolo, il «Grande Gioco», un’espressione diventata leggendaria con Kim, il romanzo di Rudyard Kipling, alludeva alla lotta d’influenza tra grandi potenze, in molti aspetti simile a quella odierna. All’epoca, la posta in gioco erano le cosiddette «Indie», il gioiello della corona britannica ambito dalla Russia imperiale (2). La lotta si protrasse per un secolo e si concluse nel 1907, quando Londra e San Pietroburgo trovarono un accordo per la suddivisione delle loro zone d’influenza, con la creazione di uno stato tampone tra di loro, l’Afghanistan (3). Questo accordo ha retto fino al 1991. Oggi, sebbene siano cambiati i metodi e le idee che guidano le grandi potenze, e i protagonisti non siano gli stessi, l’obiettivo ultimo permane. Si tratta di colonizzare, in un modo o nell’altro, l’Asia centrale per neutralizzarsi a vicenda.
Il nuovo «Grande Gioco» ha raggiunto il culmine. Con in più, questa volta, al centro del gioco, il petrolio e il gas. Ma la domanda di idrocarburi non spiega da sola la battaglia tra le grandi potenze che intendono impossessarsi dei giacimenti delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale e del Caucaso, sfuggite al dominio di Mosca con il crollo dell’Urss nel 1991. L’oro nero e l’oro grigio sono anche lo strumento di una lotta di influenza in vista del controllo del centro del continente eurasiatico. Per interposte major petrolifere, gli oleodotti sono le lunghe corde che consentono alle grandi potenze di ancorare al proprio sistema geostrategico i nuovi otto stati indipendenti (Nei) della regione (1). Nel XIX secolo, il «Grande Gioco», un’espressione diventata leggendaria con Kim, il romanzo di Rudyard Kipling, alludeva alla lotta d’influenza tra grandi potenze, in molti aspetti simile a quella odierna. All’epoca, la posta in gioco erano le cosiddette «Indie», il gioiello della corona britannica ambito dalla Russia imperiale (2). La lotta si protrasse per un secolo e si concluse nel 1907, quando Londra e San Pietroburgo trovarono un accordo per la suddivisione delle loro zone d’influenza, con la creazione di uno stato tampone tra di loro, l’Afghanistan (3). Questo accordo ha retto fino al 1991. Oggi, sebbene siano cambiati i metodi e le idee che guidano le grandi potenze, e i protagonisti non siano gli stessi, l’obiettivo ultimo permane. Si tratta di colonizzare, in un modo o nell’altro, l’Asia centrale per neutralizzarsi a vicenda.
Certo il gas e il petrolio sono ricercati in quanto tali, ma anche come strumento di influenza, spiega Muratbek Imanaliev, un ex diplomatico kirghizo (e in passato sovietico), che presiede l’Institute for Public Policy a Bichtek (Kirghizistan). Subito dopo il crollo dell’Urss, i Nei vedono nel petrolio un mezzo per rimpolpare il bilancio e rafforzare l’indipendenza nei confronti di Mosca. Alla fine degli anni 80, l’impresa americana Chevron mette gli occhi sul giacimento di Tenguiz, tra i più grandi del mondo, a ovest del Kazakistan. La Chevron ne acquista il 50% nel 1993. Sull’altra riva del Mar Caspio, il presidente azero Gueidar Aliev firma, nel 1994, il «contratto del secolo» con società petrolifere straniere, per lo sfruttamento del campo Azeri-Chirag-Guneshli. La Russia è furibonda: il petrolio del Caspio le sfugge. Essa oppone a Baku la mancanza di statuto giuridico del mar Caspio, di cui non si sa se sia un mare o un lago. Mosca si era illusa che le cose sarebbero andate meglio con Aliev piuttosto che con il suo predecessore, il primo presidente dell’Azerbaigian indipendente, il nazionalista anti-russo Albullfaz Eltchibey, rovesciato da un golpe nel giugno 1993, pochi giorni prima della firma di importanti contratti con alcune major anglosassoni. Fine conoscitore dei meccanismi del sistema sovietico, Gueidar Aliev, ex generale del Kgb ed ex membro del Politburo, tratta in segreto con i petrolieri russi per trovare un terreno di accordo con Mosca: Lukoil ottiene il 10% del consorzio Azeri-Chirag-Guneshli.
È l’inizio della lotta tra Est e Ovest per impadronirsi dei giacimenti della regione. Negli anni ’90, per giustificare la penetrazione nel bacino del mar Caspio, gli Stati uniti gonfiano le stime delle riserve di idrocarburi di quest’area. Parlano di 243 miliardi di barili di petrolio. Poco meno dell’Arabia saudita! Oggi si valutano ragionevolmente queste riserve a circa 50 miliardi di barili di petrolio e 9,1 trilioni di metri cubi di gas, ossia dal 4 al 5% delle riserve mondiali. Se gli Stati uniti si sono serviti di questo grosso bluff, è perché «essi volevano ad ogni costo costruire il Btc (l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan).
Hanno provato di tutto… per tentare di impedire l’estensione dell’influenza russa, di ostacolarla. Non so quanto sapessero di esagerare», dice Steve Levine, giornalista americano specialista di questi problemi fin dai primi anni ’90 (4). Questo gioco d’influenza s’imballa. Approfittando della «guerra contro il terrorismo» in Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre, i militari americani si insediano nella ex-Urss. Con la benedizione di una Russia indebolita. Washington insedia le sue basi nel Kirghizistan e nell’Uzbekistan, promettendo di lasciare questi paesi appena sarebbe stata sradicata la cancrena islamista. «Bush si è servito di questo impegno militare massiccio nell’Asia centrale per suggellare la vittoria della Guerra fredda contro la Russia, arginare l’influenza cinese e mantenere il nodo scorsoio intorno all’Iran», dice Lutz Kleveman, ex corrispondente di guerra (5). Inoltre Washington svolge un ruolo determinante nelle rivoluzioni colorate in Georgia (nel 2003), in Ucraina (2004) e nel Kirghizistan (2005) che sono altrettanti pesanti scacchi per Mosca (6). Sconvolti da questi rovesciamenti di potere in serie, alcuni autocrati della regione voltano le spalle all’America e si riavvicinano alle Russia o alla Cina. Infatti il gioco si è complicato negli ultimi anni man mano che Pechino si intrometteva negli affari dell’Asia centrale e che l’Europa, in seguito alla guerra del gas tra Russia e Ucraina del gennaio 2006, accelerava i suoi progetti di captazione dell’oro grigio caspico. Petrolio, sicurezza, lotta d’influenza e battaglie ideologiche: bisogna puntare su tutti i fronti per cavarsela in questo «Grande Gioco». Inizialmente, la Russia è chiaramente in vantaggio in questo braccio di ferro: nel 1991, controlla tutti gli oleodotti che consentono ai Nei di trasportare i loro idrocarburi. Ma gli apparatchiki diventati presidenti si sforzano di non mettere tutte le loro uova nel paniere russo. Dopo la caduta dell’Urss, vengono costruiti una mezza dozzina di oleodotti che non attraversano il territorio del grande fratello: Mosca perde così parte del suo peso politico ed economico. Un tempo sconvolta dalla presenza militare americana e dalla serie di «rivoluzioni colorate», Mosca si rafforza nei paesi vicini L’esempio del Turkmenistan è emblematico delle relazioni della Russia con i territori del suo antico dominio: dei 50 miliardi di metri cubi di gas prodotti nel 2006 nel Turkmenistan, 40 sono stati venduti alla Russia. Scelta obbligata. A parte un piccolo gasdotto inaugurato nel 1997, che lo collega all’Iran, il Turkmenistan dispone solo del Sac-4, un oleodotto che arriva in Russia. Una catena vera e propria.
E, nell’aprile 2003, il presidente russo Vladimir Putin è in grado di costringere il suo omologo turkmeno Saparmurad Niazov (scomparso alla fine del 2006) a firmare un contratto di 25 anni per 80 miliardi di metri cubi all’anno, venduti al prezzo ridicolo di 44 dollari/1000 m3. Ben presto Achkhabad cerca di rimettere in questione queste condizioni e blocca le consegne. Nell’inverno 2005 Mosca si rassegna a pagare 65 dollari/1000 m3 perché il gas turkmeno è indispensabile in particolare per rifornire a basso prezzo la popolazione russa. Nel settembre 2006, Gazprom va oltre e firma un contratto con Achkhabad impegnandosi, per il periodo 2007-2009, a pagare 100 dollari/1000 m3. Questo perché, cinque mesi prima, in aprile, il dittatore scomparso aveva firmato con il presidente cinese Hu Jintao un documento che impegnava il Turkmenistan a fornire alla Cina, per una durata di trent’anni, 30 miliardi di metri cubi di gas naturale ogni anno, a partire dal 2009, e a costruire un gasdotto lungo 2000 chilometri. Questo spiega probabilmente perché Gazprom ha dovuto alzare le sue tariffe. Forse Achkhabad vuole ancora alzare il prezzo? Dopo la sua prima visita ufficiale a Mosca in veste di presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov invita Chevron a partecipare allo sviluppo del settore energetico turkmeno. Mai il suo predecessore aveva osato fare simile proposta a una major internazionale. Peraltro il presidente non respinge le proposte europee riguardanti il corridoio transcaspico. E’ possibile che minacci di far entrare gli occidentali nel suo gioco per spingere Gazprom ad accettare un prezzo più alto – infatti all’Europa chiede più di 250 dollari/1000 m3. Eppure Putin aveva proposto di restaurare il SAC-4 e di costruire un altro gasdotto che collegasse i due paesi. «La Russia vuole mostrare ai turkmeni che è pronta a fare molto per loro. Mosca spera di dissuaderli dal trattare con i cinesi e gli occidentali», osserva il giornalista russo Arkady Dubnov. «La battaglia che Mosca deve condurre contro il Turkmenistan dimostra che la Russia non è più onnipotente nelle ex repubbliche sovietiche e che ciò che prevale oggi è il pragmatismo economico di Putin e della sua cerchia», conclude questo esperto della Comunità degli Stati indipendenti (Cei). Il 12 maggio scorso durante una visita di una settimana in Asia Centrale, Vladimir Putin ha firmato con i suoi omologhi turkmeno e kazaco un accordo per l’ammodernamento del gasdotto Cac-4 e la costruzione di un altro tubo, destinati a trasportare il gas del Turkmenistan in Russia. È in gran fretta che il presidente russo è arrivato a Turkmenbachi per strappare questo accordo, proprio mentre un analogo vertice concorrente era organizzato nello stesso periodo a Cracovia, in Polonia. Là svariati paesi situati ai margini della Russia speravano di lanciare oleodotti ostili. Il presidente kazaco ha perfino dovuto rinunciare a recarvisi per accogliere Putin. Come è riuscita la Russia a raggiungere i propri fini? Essa sembra avere argomenti che ne fanno ancora e senza dubbio per un lungo periodo, la più potente delle grandi potenze in Asia centrale. Pechino e Bruxelles hanno di che preoccuparsi per i per i loro progetti di approvvigionamento in Asia centrale.
Il metodo russo ha l’inconveniente di essere spesso brutale. Per questo, nel 2005, la crisi del gas tra Mosca e Kiev è stata sofferta dagli europei (7). Lo spettro dell’interruzione delle forniture aleggiava sul vecchio continente che importa un quarto del suo gas dalla Russia.
Tuttavia, sdrammatizza Jérôme Guillet, autore di uno studio sulle guerre del gas del 2006, queste crisi sono «lo specchio delle lotte che si tramano nelle quinte tra fazioni potenti all’interno del Cremlino o in Ucraina, più che l’effetto di un uso deliberato dell’arma energetica» (8).
Primo produttore mondiale di gas e secondo di petrolio, la Russia ha ritrovato la tranquillità finanziaria e prende iniziative strategiche.
Il 15 marzo scorso, ha firmato un accordo con la Bulgaria e la Grecia per la costruzione dell’oleodotto Burgas-Alexandroupoli (Bap). Un vero concorrente per il Btc e, meglio ancora, il primo che lo stato russo controlli sul territorio europeo. Parimenti, da alcuni mesi, il grezzo scorre lungo i 1.760 chilometri del Btc come il gas nel Baku-Tbilissi-Erzurum (Bte). L’arteria vitale dell’influenza occidentale nella ex-Urss funziona e produce i primi effetti politici. Da quest’anno, la Georgia sembra dipendere un po’ meno dal gas russo, mentre un anno fa, non poteva importarne altro. Gli aumenti clamorosi imposti dalla Russia – in due anni, il gas è passato da 55 a 230 dollari/1000 m3. – hanno colpito l’economia georgiana meno di quanto Mosca si aspettasse. Le quantità fornite dal Bte a titolo di royalty, e dalla Turchia, che cede a prezzo di affezione la parte di gas che le spetta per questo gasdotto, hanno permesso alla Georgia di comporre un prezzo medio accettabile (9). Peggio ancora per Mosca: il tentativo di imporre all’Azerbaigian un aumento dei prezzi nella stessa misura, nella speranza che colpisca di rimando le forniture destinate a T’bilisi, ha fortemente irritato il presidente Ilham Aliev. «Questo prova che il Btc (come il Bte) rappresenta senza dubbio la più grande vittoria americana in politica internazionale negli ultimi quindici anni. Un successo in fatto di “containment” della Russia e di sostegno all’indipendenza delle repubbliche caucasiche», sostiene Steve Levine. Questi oleodotti offrono agli Stati uniti e all’Europa la possibilità di lanciare due progetti per diversificare le loro fonti di approvvigionamento e attrarre nella loro cerchia politica i Nei della regione. Il primo, il Kazakhstan Caspian Transportation System (Kcts), destinato a convogliare il petrolio del giacimento di Kachagan, il più grande scoperto nel mondo negli ultimi trent’anni. La produzione deve iniziare alla fine del 2010, e gli azionisti del consorzio incaricato dello sfruttamento di questo giacimento, composto da grandi majors occidentali (10), si propongono di trasportare da 1,2 a 1,5 milioni di barili al giorno lungo un itinerario sud-ovest che attraverserà il mar Caspio.
Impossibile far passare l’oleodotto sotto il mare a causa dell’opposizione dei russi e degli iraniani: una flotta di petroliere farà la spola tra il Kazakistan e l’Azerbaigian, dove un nuovo terminal petrolifero collegherà il «sistema» al Btc. Questo, grazie ad alcune stazioni di pompaggio supplementari e all’uso di prodotti destinati a dinamizzare il passaggio dell’olio nelle tubature, dovrebbe avere un aumento della capacità da 1 a 1,8 milioni di barili al giorno. Il secondo progetto riguarda l’«oro grigio» ed è per ora appena abbozzato: si tratta del «corridoio transcaspico», destinato a rifornire l’Europa di gas kazako e turkmeno. «Parliamo di “corridoio” e non di gasdotto – precisa Faouzi Bensara, consigliere per l’energia alla Commissione europea – Proponiamo di avviare una riflessione su soluzioni tecnologiche alternative, come incoraggiare investimenti per la produzione di gas naturale liquefatto nel Turkmenistan, ad esempio, il quale potrebbe in seguito essere trasportato via nave fino a Baku». L’Unione europea non vuole essere protagonista del «grande gioco», precisa questo alto funzionario: «L’Ue è motivata solo dal suo bisogno. Presto ci occorreranno da 120 a 150 miliardi di metri cubi di gas all’anno.
Il nostro obiettivo è trovare questi volumi supplementari e diversificare le nostre fonti di approvvigionamento. Nient’altro. Individueremo soluzioni che saranno complementari a quelle che già esistono».
In compenso, un altro grande pipeline strategico promosso da Washington ha scarse possibilità di attuazione: si tratta del Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), il famoso gasdotto che gli Stati uniti, con la società petrolifera americana Unocal, si ripromettevano di costruire con i taliban nella seconda metà degli anni ’90. «Questo progetto comporta troppi inconvenienti, riguardanti la sicurezza, con il ritorno dei taliban in Afghanistan.
Peraltro, molti esperti ritengono che le riserve del Turkmenistan non siano state correttamente valutate», dice il professore Ajay Kumar Patnalk, specialista della Russia e dell’Asia centrale all’università Jawaharlal Nehru, a New Delhi.
Washington difendeva il Tapi, sia per isolare l’Iran, sia per indebolire la Russia nell’Asia centrale. Ormai, gli Stati uniti intendono integrare l’Afghanistan tra i paesi vicini e allo stesso tempo fornirgli risorse per riscaldare le sue popolazioni e rilanciare la sua economia, come pegno della sua stabilità. In questo senso, nel 2005, il dipartimento di stato americano ha riorganizzato la sua divisione Asia del Sud fondendola con la divisione Asia centrale, per agevolare le relazioni a tutti i livelli in quest’area designata come «Grande Asia centrale».
L’energia costituisce uno dei vettori essenziali delle relazioni interne nella regione. Sono quindi nati diversi progetti di centrali idroelettriche, ad esempio nel Tagikistan, destinati ad alimentare il Nord afghano. Ma l’idea nel suo insieme non va avanti. New Delhi in particolare, si sente lontana dall’Asia centrale ed esita a diventare parte integrante del Tapi. Sarebbe più attratta dal progetto di gasdotto Iran-Pakistan-India (Ipi), proposto da Tehran, sebbene l’Iran-Libya Sanctions Act (Ilsa) – mediante il quale Washington punisce ogni impresa che investa nel petrolio o il gas di questi paesi – vieta a New Delhi di fare il passo. «L’Iran è il grande perdente del nuovo “grande gioco”. Non solo gli oleodotti aggirano il suo territorio, ma nessuno può investire in Iran – rileva Mohammed Reza-Djalili, specialista iraniano delle relazioni internazionali dell’Asia centrale – . Ma sono proprio gli investimenti che mancano in questo paese. Le sue installazioni risalgono agli anni 1970, sicché l’Iran è costretto a importare il 40% della sua benzina. Non ha potuto esplorare la sua parte del mar Caspio e il suo enorme potenziale di gas solo parzialmente sfruttato». Peraltro è paradossale che il «Grande Gioco» escluda Tehran, mentre i produttori di idrocarburi nell’Asia centrale sognano una via meridionale: «Può essere meno caro e piuttosto semplice sul piano tecnico – spiega Arnaud Breuillac, direttore Total per l’Europa centrale e l’Asia continentale. Siamo in una logica di diversificazione delle nostre vie di esportazione. In questo quadro, abbbiamo preso un’opzione sulla via sud, tanto più che la regione di consumo più vicina al mar Caspio è il nord Iran». Questo spiega perché il riavvicinamento con l’Organizzazione di cooperazione di Shanghai (Ocs) (11) rappresenti in questo contesto, secondo Reza-Djalili, «un salvagente della politica iraniana nell’Asia centrale. Per questo tramite, Tehran può intrecciare legami con l’Asia, in particolare con la Cina, e rafforzarsi nel suo braccio di ferro con gli Stati uniti». Da parte sua, la Cina – spiega Thierry Kellner, specialista della Cina e dell’Asia centrale – persegue tre obiettivi in questo «Grande Gioco»: «La sua sicurezza, in particolare nella provincia turcofona dello Xinjiang, che fiancheggia l’Asia centrale; la cooperazione con i vicini, per impedire che un’altra grande potenza diventi troppo potente nello spazio centro-asiatico; infine l’approvvigionamento energetico». I numerosi acquisti di diritti di estrazione petrolifera di Pechino in Asia centrale, da alcuni anni, hanno fatto correre molto inchiostro. Nel dicembre 2005, la Cina inaugurava addirittura un oleodotto che collega Atassu, nel Kazakhstan, ad Alachanku, nello Xinjiang. «Il primo contratto petrolifero firmato da Pechino nell’Asia centrale risale al 1997 – rileva Kellner. La Cina lavora sul lungo termine. Ha saputo costruire basi solide nell’Asia centrale, e oggi questa politica paga».
Questa frenesia di acquisti non risponde soltanto alla richiesta di idrocarburi in un paese che ha una crescita annua del 10%. Secondo Kellner, traduce anche la sua visione geopolitica: «La Cina non vede le cose in termini di mercato, sebbene l’offerta e la richiesta di petrolio siano globalizzate. Per garantire la propria sicurezza energetica, si offre giacimenti e oleodotti che ne assicurano l’approvvigionamento diretto, ma che sono molto costosi. Mentre è essenziale che offerta e domanda si equilibrino a livello mondiale per mantenere i prezzi.
Nel suo stesso interesse, Pechino dovrebbe piuttosto contribuire a questo equilibrio senza necessariamente pensare ai propri approvvigionamenti diretti».
Le ex repubbliche sovietiche sfruttano la concorrenza tra le grandi potenze per consolidare la propria indipendenza economica e politica Investire nell’Asia centrale significa anche, per i cinesi, la possibilità di inserirsi negli affari della regione per contribuire alla sua sicurezza – così dicono. Pechino si impegna nell’Ocs per federare gli stati membri sui temi prediletti, come la lotta contro il terrorismo o la cooperazione economica ed energetica. Di più, l’organizzazione forma un blocco in grado di creare una forte solidarietà in caso di destabilizzazione della regione, o di accresciuta influenza degli Stati uniti che potrebbero arrivare al punto di minacciare i poteri costituiti. L’ondata di «rivoluzioni colorate» nello spazio ex-sovietico a partire dal 2003 ha così portato l’organizzazione a prendere una posizione più netta contro Washington. Nel luglio 2005, ad esempio, i suoi sei membri sostenevano Tashkent nella sua esigenza di chiudere la base militare aerea americana di Karshi-Khanabad, aperta nel quadro dell’operazione in Afghanistan. In effetti, non esiste più nessun Gl sul suolo uzbeko. In realtà, il «grande gioco» conviene alle repubbliche d’Asia centrale e del Caucaso che puntano sulla concorrenza tra le grandi potenze.
Diventano un po’ più indipendenti, in quanto possono dire di «no» a una di queste grandi potenze per rivolgersi a un’altra grande capitale.
Il che spesso significa soprattutto scegliere la propria dipendenza.
Mentre il Kazakistan apre la sua economia al mondo, l’Uzbekistan la chiude, e mentre la Georgia punta fino in fondo sulla carta americana, il Turkmenistan conserva una profonda sfiducia nei confronti di Washington.
Al di là di queste differenze, il «grande gioco» consente loro di essere meno costrette a seguire la strada imposta da una delle potenze dominanti. Ad esempio, se il discorso democratico dell’Occidente compromette gli interessi dei dirigenti centro-asiatici o caucasici, essi possono comunque voltargli le spalle, visto che né Pechino né Mosca sono molto rigorosi in materia. A dire il vero, nemmeno Washington o Bruxelles lo sono sistematicamente.
Gli imperativi strategici li portano spesso a relegare i diritti della persona in secondo piano, cosa che discredita notevolmente i valori cosiddetti «occidentali», nei quali i poteri della regione non vedono altro che un’arma ideologica. Dopo il 2003, per mettere a tacere le critiche, i loro dirigenti perfezionano, mese dopo mese, un discorso sul loro modo «orientale», di costruire la democrazia a casa propria. Nel frattempo, la corruzione regna in questo «grande gioco»: la manna del petrolio e del gas, anche se si tratta di ricchezze nazionali, sfugge in gran parte al controllo democratico degli abitanti di questi paesi.note:
* Giornalista indipendente, Bishek (Kirghizistan)
(1) Si legga Vicken Cheterian, «Il “Grande Gioco” del petrolio in Transcaucasia» e «L’Asia centrale, retrovia americana», Le Monde diplomatique/il manifesto, rispettivamente ottobre 1997 e febbraio 2003.
(2) La teoria dello Heartland si deve al britannico Halford John Mackinder (1861-1947). Padre della geopolitica contemporanea, egli concepiva il pianeta come un insieme che gira intorno al continente eurasiatico, lo Heartland. Per dominare il mondo, occorre dominare questo «perno geografico del mondo». Mackinder riteneva che la Russia, padrona dell’Heartland a causa della sua posizione geografica, possedesse una superiorità strategica sulla Gran Bretagna, potenza marittima.
(3) Sul «grande gioco», cfr. Peter Hopkirk, The Great Game, On Secret Service in Central Asia, Oxford University Press, New York, 1991.
Per un breve riassunto, cfr. Boris Eisenbaum, Guerres en Asie centrale.
Luttes d’influences, pétrole, islamisme et mafias, 1850-2004, Grasset, Parigi, 2005.
(4) Egli pubblicherà il prossimo ottobre un libro intitolato The Oil and the Glory: The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea, Random House, New York, 2007.
(5) «Oil and the New “Great Game”», The Nation, New York, 16 febbraio 2004.
(6) Si legga Vicken Cheterian, «Le strane rivoluzioni che avvengono all’Est», Le Monde diplomatique/il manifesto, ottobre 2005.
(7) Si legga Vicken Cheterian, «La rivoluzione arancione si scolora», Le Monde diplomatique/il manifesto, settembre 2006.
(8) Jérôme Guillet, «Gazprom, partenaire prévisibile: relire les crises énergétiques Russie-Ukraine et Russie-Belarus», Russie, NeiVisions, n° 18 Ifri, marzo 2007. Per una visione opposta, cfr. Christophe-Alexandre Paillard, «Gasprom: mode d’emploi pour un suicide énergétique», Russie, Nei Visions, n° 17 Ifri, marzo 2007.
(9) Cfr. «La Géorgie tente de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie», Bulletin de l’industrie pétrolière, Parigi, 8 febbraio 2007.
(10) Gli azionisti di Agip Kco sono Eni (18,52%), ExxonMobil (18,52%); Shell (18,52%), ConocoPhillips (9,26%), la società nazionale petrolifera kazaka KazMunayGas (8,33%), Inpex (8,33%).
(11) L’Ocs è stata creata nel 1996 con la denominazione di «gruppo di Shanghai». Comprende oggi sei Stati membri (Cina, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Russia, Tagikistan) e quattro osservatori (India, Iran, Mongolia, Pakistan). Questo ultimo statuto di osservatore è stato negato agli Stati uniti. -
L’Oriente e l’Occidente si contendono l’oro nero
| San Francisco Chronicle | Domenica 9 dicembre 2007 | Kelly McEvers |
In 1859, a retired railway conductor named Edwin Drake struck oil in a tiny Pennsylvania town called Titusville. Back then, crude was refined for use in kerosene lamps. Soon, the Drake Well was pumping hundreds of thousands of barrels of oil. The Petroleum Age was under way.
Yet few Americans know that a decade before this amazing discovery, the world’s first commercial oil well had already been plumbed on a peninsula far from Pennsylvania, a peninsula whose name means “place of salty waters” – a hook of land that juts into the briny Caspian Sea.
Landlocked by Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Russia, Azerbaijan – names that Americans these days might associate with an abundance of natural resources – the Caspian Sea is actually a lake, but one that happens to blanket some of the world’s largest oil and gas fields.
To spend time in any of these countries, four of which once belonged to the Soviet Union, is to see the names such as Chevron and BP emblazoned on everything from stationery to shipping containers and to wonder, how did Western companies get here?
Steve LeVine, an energy correspondent for the Wall Street Journal who covered the Caspian region from 1992 to 2003, answers this question in surprising detail in “The Oil and the Glory.” Chance meetings on planes, Connecticut mansions, CIA debriefings, Caribbean yacht cruises, Gulfstream jets – all these are set pieces in LeVine’s account of how, long before it was official policy, Western oilmen “instinctively grasped the essence of détente” with the Evil Empire, and found ways to open it up for business.
Oil dealings between the West and Soviet Union started as far back as 1928, when Joseph Stalin launched a five-year plan to revive Soviet industry and “unabashedly employed Americans and Europeans” to develop the oil fields off the Caspian Sea.
Later, after World War II, when the Allies’ relationship with Stalin soured and the Cold War began, it took middlemen, such as a flamboyant Turkish Armenian emigre in Boston and his protege, a wily California social climber, to open doors for Western oilmen in an otherwise closed Soviet Union.
That Californian was Jim Giffen, who golfed and glad-handed his way to a job as chief adviser to Chevron, which eventually signed a momentous deal to drill and manage day-to-day operations at a “supergiant” oil field called Tengiz, just off Kazakhstan in the Caspian Sea – and keep 20 percent of the profits.
Giffen seemed to know all the right hands to shake in late 1980s Moscow, especially after Soviet President Mikhail Gorbachev legalized joint ventures with the West, and later in Kazakhstan, when it and other republics gained independence and were able to negotiate oil deals on their own.
Throughout that heady, chaotic time, Giffen had a particular ability to make it appear as if his proposals for American companies to exploit Soviet oil fields had the blessing of Washington. The dominant feature in Giffen’s New York office, LeVine writes, was photographs of Giffen with key players in the U.S. government and big oil, including one of Condoleezza Rice, who then was on Chevron’s board of directors.
Yet even Giffen couldn’t have predicted how swiftly the Soviet Union would collapse – or how fiercely his allies in Moscow would try to thwart Western ventures in the newly independent, post-Soviet republics.
The Chevron-Tengiz deal in Kazakhstan, for instance, got much more complicated when the company was forced to transport its crude through old, small Soviet pipelines, where high-quality Tengiz oil had to mix with a blend of lower-quality Russian crude, and Russia charged high tariffs for the privilege.
So began a policy shift in the United States – away from opening up to the entire post-Soviet region in favor of exploiting Caspian oil while containing Russia. But this policy shift did not come easily, LeVine reports, especially given the influence over then-President Bill Clinton of his longtime friend and deputy secretary of state, Strobe Talbott, who believed that the awakening giant, Russia, must be appeased at all costs.
Eventually, though, midlevel players in the administration were able to make the case that it was in America’s interest to support an oil pipeline from East to West that circumvented Russia, and archrival Iran. The plan was to start the pipeline at the Caspian, travel over the mountains of newly independent Georgia and end at the Turkish port of Ceyhan, on the Mediterranean Sea.
LeVine meticulously recounts the process of getting this pipeline built – a process that spanned more than a decade and several administrations in a handful of countries – painting a rare picture of how a few determined policymakers can alter the geopolitical map.
That level of detail seems gratuitous the few times LeVine talks to townspeople in these far-flung republics, people without indoor plumbing who gained little from the oil boom. These passages seem too quick and too forced, as does a chapter on a failed Unocal plan to build a pipeline across Afghanistan. The only real scoop here is that the company bought and installed a fax machine for the Taliban.
Otherwise, “The Oil and the Glory” is a fine, gripping read, one that takes us to a once-forbidden land, and shows us how many others have gone before us – and prospered. -
Il petrolio e la gloria di Steve LeVine
| Conde Nast Portfolio | Novembre 2007 | Andy Young |
The Caspian Sea region’s oil was commercialized in 1886, when Zeynalabdin Tagiyev—known as the Azerbaijani Eunuch Maker—struck a gusher that spewed more crude into the sea than all the world’s functional wells were producing at the time. As LeVine’s engaging account details, the area has since been discovered, plundered, and forgotten time and again. But now, with the opening of the Baku-Ceyhan pipeline in spring 2006, the Caspian may well be the key to our energy independence from the Middle East. A former Wall Street Journal writer, LeVine brings this all alive by introducing us to regional strongmen, American fixers, Western oil-company executives, and shady energy traders who, since the breakup of the Soviet empire, have jostled for Central Asia’s enormous oil prize while Mother Russia looms menacingly in the background. The deft political portrait of this strategic, volatile area makes the book essential reading, but it’s LeVine’s fine writing that makes it a pleasure.
-
Il petrolio e la gloria. La corsa al dominio e alle ricchezze della regione del Mar Caspio
| Foreign Affairs | Novembre/Dicembre 2007 | Robert Legvold |
Hardly any topic has been more chewed over in recent years than the politics of Caspian Sea oil and gas. But behind the reported head butting of governments, the play-by-play over pipelines, and an endless stream of academic conferences, a bare-knuckle, swashbuckling drama has pitched and rolled, with oilmen vying for a share of these riches. LeVine, a correspondent for The Wall Street Journal, has done due diligence in framing both the historical and the contemporary political settings, but the treat is in the roiling tale of the gambles, bravado, and maneuvering of the dealmakers. James Giffen, the impresario of Kazakhstan’s oil surge, now under indictment in U.S. court, plays a central role, but there are many others in the cast. Like a good scenarist, LeVine develops the characters for each segment before proceeding with the plot. For people who liked Michael Douglas in Wall Street, here is an even more subtle and complex movie script.
-
La corsa al petrolio nel Mar Caspio
| BusinessWeek | Lunedì 12 novembre 2007 | Stanley Reed |
The disintegration of the Soviet Union in the early 1990s unleashed a modern-day Klondike in the bleak but oil-soaked region around the Caspian Sea. Stories of how companies such as Chevron (CVX ) and ExxonMobil (XOM ) gained access to the huge oil fields of Kazakhstan and Azerbaijan have leaked out in dribs and drabs, but now Steve LeVine has gathered the whole Wild East tale in one canny and entertaining book, The Oil and the Glory: The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea.
LeVine, who spent many years in Russia and its neighbors as a correspondent for The Wall Street Journal and other publications, has filled his volume with intriguing, sometimes daunting characters. Ludvig Nobel, a 19th century entrepreneur and member of the famed Swedish family, organized the Caspian oil trade much as John D. Rockefeller did the U.S. business. Zeynalabdin Tagiyev, an Azeri oil baron of the 1880s, once ordered servants to castrate a rival for his wife’s affections. Marat Manafov, Azerbaijan’s oil negotiator during the 1990s, shook up meetings by pointing a pistol at Western oil executives.
More important, the book zooms in on the dubious practices, intrigue, and political arm-twisting that can be a key part of deals in developing nations, where ever more of the oil business takes place. In Kazakhstan in the 1990s, large sums from oil companies allegedly ended up in the Swiss bank accounts of the country’s President. At the same time, in Azerbaijan, a $230 million “signing bonus” paid by a consortium of Western companies was almost instantly dispersed “to offshore accounts in countries with lax banking laws,” according to a Pennzoil official quoted by LeVine.
LeVine also underscores the intensely political nature of oil. Both Russia and the U.S. employed government muscle to influence which companies gained access to Caspian countries’ reserves and the routes through which it would be exported. Al Gore tried to use his Vice-Presidential clout in Chevron’s favor against the maverick Dutch oil trader John Deuss. Deuss, playing a clever but ultimately losing game, was trying to parlay the backing of the Sultan of Oman into a lock on the vital pipeline route out of Kazakhstan.
Much less interesting than such characters, in LeVine’s telling, are the oil company executives, who are burdened both by a sense of entitlement and a tin ear for local politics. BP’s John Browne, then head of the company’s exploration and production, did impress his Kazakh hosts by gulping down a local delicacy—a sheep’s eye. But, says LeVine, Chevron CEO Kenneth Derr “literally turned his back” on Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev when he asked for help in building a soccer stadium for his new capital, Astana. Nazarbayev, whose oil Derr coveted, “was suitably flabbergasted and insulted.”
A key figure in much of the Caspian intrigue was one James H. Giffen, the son of a Stockton (Calif.) haberdasher who became a player in the hard-to-penetrate world of U.S.-Soviet trade. In the mid-1980s, Giffen convinced Soviet leader Mikhail Gorbachev that U.S. business could help cure his country’s ailing economy. The apex of Giffen’s career: the deal he brokered giving Chevron exclusive rights to Kazakhstan’s Tengiz, a gem of an oil field that is probably among the world’s 10 largest. In return, says LeVine, Giffen got 7.5 cents on each barrel Chevron produced, potentially tens of millions of dollars.
For years Giffen, a frequent source for BusinessWeek reporters, masterfully juggled different interests, including the Kazakhs, the oil companies, and the CIA. He and Nazarbayev “sometimes retreated into the countryside for days at a time, accompanied by young Kazakh women and well supplied with whiskey.” But his influence waned, and in 2003 he was arrested at New York’s John F. Kennedy International Airport on charges of funneling $77 million in bribes from U.S. oil companies to Nazarbayev and other Kazakh insiders.
He still awaits trial, insisting that he had been, in LeVine’s words, “a U.S. agent in Kazakhstan…in one of the most strategic regions in the world.” Whatever happens to him, the spot is sure to spawn other outrageous characters to take his place. -
Il petrolio e la gloria. La corsa all’impero e alla fortuna del Mar Caspio di Steve LeVine
| Registan.net | Domenica 21 ottobre 2007 | Joshua Foust |
For well over a century, the Caspian basin has been “the next big thing” for energy, a potentially wealthy region crippled only by its inaccessibility. This was the result of technology in the nineteenth century, when oil was exported on muleback, and later ideology, when the Bolsheviks seized Western assets, and the Soviets later denied westerners access only until they desperately needed cash. Since “The Fall,” the mad scramble for the region’s oil and gas has reached a fever pitch, resulting in the destruction of several large companies, the acquisition of others, and an incredible degree of political and commercial back-dealing and betrayal.
This story, which most only know in a general sense (if at all), is the story LeVine lays out. The primary author of a blog which shares its name with his book, LeVine was a regional correspondent for the New York Times and the Almaty bureau chief for the Wall Street Journal. Such a position gave him key access to many of the players he describes—from the hilariously pompous middlemen like James Giffen to heads of state like Nursultan Nazarbayev—and a bracing, spellbinding narrative full of intrigue to tie together an incredibly complex story.
While the broadest strokes of this story aren’t especially new (regular readers of most blogs or news accounts of Central Asia won’t find world-altering surprises), LeVine adds value by not only placing the current geopolitical wrangle in a broad historical context, but by offering deep insights into what each of the players was thinking, as well as all of the messy back room negotiations that created the modern Caspian. This is where his access as a journalist really comes out to shine: he had the benefit of collecting interviews and notes over more than a decade, all of which allowed him to craft what could be a definitive history not just of the struggle for Caspian oil, but of the men who struggled for it. New characters, mostly if not always unheard of pop in and out of the story, sometimes changing it but always adding intrigue. For example, the erratic behavior of Azeri negotiator Marat Manafov, remembered mostly for drawing a pistol on oil executives at a posh hotel, was mind-boggling to read, especially in such a serious context and with such huge stakes.
Much like Steve Coll’s masterpiece on the CIA-al-Qaeda struggle throughout the 80s and 90s, this insider access is incredibly valuable, but only gets you so far: at some point, the realization sets in that this is everyone’s personal interpretation and spin of what happened and what they were thinking. While it’s true that this the case of most histories, the reliance on personality leaves big gaps that I wish could be filled in, most especially what was happening on the Russian side. We learn a great deal about what the Clinton White House was thinking (and internally debating) during the mad rush of the 90s, much of what the major oil executives were up to, and even a surprising amount of the normally hyper-private middlemen. There is keen insight into what the Azeris and Kazakhs were trying to get. But the coverage of Russia felt oddly flat.
This isn’t much of a criticism—there are only so many people one can talk to, even over a decade, especially on a subject as intensely sensitive (and especially so in Russia) as oil rights and exploration and politics. But while such an exercise gains one an incredible glimpse into how the oil industry operates, and more importantly how it plays into national and international politics, it can only go so far.
Indeed, while this is a glorious history written in the vein of Hopkirk’s The Great Game, it is short on analysis. While LeVine raises appropriate and troubling questions—such as Russia’s reliability as an honest broker or trading partner, and whether America’s self-insertion into the region will be for good or ill—there’s not much here to help in answering them.
The history, however, is indeed glorious. I found the opening section, in which LeVine details the first Baku boom a century ago, of incredible interest. Aside from the gaudy excesses of the original barons (the current ones are more discreet in how they blow millions on luxury), what was most striking was the incredible waste. This was something even the contemporary Europeans, such as the descendants of Alfred Nobel (who not only were the primary developers in Baku, but also invented the modern oil tanker), found shocking. Wells would be tapped and left as gushers, spewing untold amounts of wealth into the air and then into the ground, making everything a soupy, useless, toxic mess. This horrendous waste and pollution, unfortunately, continued through the Soviet era, right to the 1985 Tengiz blowout that burned for over a year. 85 miles away, 700-ft tall column of flame was visible, and apparently it was so hot water boiled from nearly 200 feet away.
There’s another untold story there, one perhaps worthy of follow up: the unbelievable environmental damage the Soviets wrought, in Central Asia (mostly Kazakhstan, as the Aral Sea, Semipalatinsk, and Tengiz disasters may indicate), but across the entire USSR. Oil is a messay, dangerous industry—that much everyone can agree to (and the battle over preserving the wildlife refuges off Sakhalin speak to some long-overdue push back against reckless exploration). But so is communism, both in the hundred million people sacrificed to its ideology last century and the continued legacy of the scars its land bears. LeVine’s book is an important part of this story, and is so well written it is worth reading even if one has no interest on the subject. But it is only a part of a much grander, and sadder, story. -
Nel vortice del petrolio
| Panorama.it | Giovedì 24 Gennaio 2008 | Pino Buongiorno |
Sono potenti. Sono celebri. Ma quest’anno sono anche terribilmente ansiosi. I 2.450 partecipanti all’annuale appuntamento del World economic forum di Davos, sulle Alpi svizzere, dal 23 al 27 gennaio, sanno che è iniziato un anno di straordinarie incertezze politiche ed economiche, come mai negli ultimi due decenni.
Prima di partire per la «Magica montagna» tanto cara a Thomas Mann, i capi di stato e di governo, gli imprenditori delle multinazionali, gli accademici e gli scienziati di fama hanno ricevuto un voluminoso rapporto intitolato «Rischi 2008». Il livello di allarme, segnalato dai 100 top manager ed esperti intervistati, è altissimo sia per i timori crescenti di un’imminente stagnazione americana ed europea sia per il vuoto politico che si è venuto a creare nell’anno delle elezioni presidenziali in Russia e in America. «È un futuro di sfide eccezionali» avverte Klaus Schwab, il fondatore del World economic forum. «Ma anche di opportunità per dimostrare le capacità di leadership».
In soli 12 mesi il pianeta è cambiato profondamente. L’anno scorso si discuteva di cambiamento del clima. L’agenda politica del 2008 rimette al primo punto la sicurezza delle fonti energetiche, come all’inizio degli anni Ottanta. La politica estera americana ha sempre avuto come principio guida quello di evitare che altre nazioni potessero usare l’oro nero per far avanzare le proprie pretese egemoniche. Dunque, petrolio accessibile per tutti, a prezzi di mercato. Ma diversi mutamenti nel rapporto domanda-offerta ora minacciano questo sistema.
Il gap tende a ridursi, la produzione è ai massimi livelli e i consumi, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia, crescono esponenzialmente: dagli 87 miliardi di barili attuali ai 110 miliardi fra una decina di anni.
Nell’era dei 100 dollari al barile, la fatidica soglia toccata il 2 gennaio scorso, i paesi produttori festeggiano una prosperità senza precedenti: 700 miliardi di dollari in più solo nel 2007. La conseguenza fin troppo ovvia è che alcuni di essi, Russia in particolare (ma anche Venezuela), vogliono giocare un ruolo politico assai più incisivo.
Nello stesso tempo la sete di petrolio scuote i paesi consumatori (Usa, Unione Europea, Giappone, India e Cina), che si lanciano in una caccia spasmodica all’ultima goccia di greggio, facendo venire meno le vecchie alleanze e snaturando le regole del mercato.
Terzo: le grandi compagnie petrolifere perdono progressivamente terreno nei paesi produttori. Devono affrontare un pericoloso «nazionalismo delle risorse» che porta a utilizzare l’energia come arma politica privilegiata. Sono domande fin troppo retoriche quelle che si pone un recente rapporto del National petroleum council americano: «La competitività per le risorse sempre più scarse sfocerà in conflitti politici e anche militari fra le maggiori potenze?».
E ancora: «Gli accordi bilaterali fra le nazioni diventeranno comuni, nel momento in cui i governi tentano di assicurarsi i prodotti energetici al di fuori dei tradizionali meccanismi di mercato?». La realtà, al di là delle previsioni più fosche, è che l’ordine mondiale è stato sconvolto. La superpotenza americana non detta più legge da sola e soprattutto non ha più l’influenza di una volta. Quando George W. Bush arrivò alla Casa Bianca, nel gennaio 2001, il barile costava 30 dollari. Quando iniziò il secondo mandato, nel gennaio 2005, era salito a 48 dollari, fino ai 100,1 dollari del 2 gennaio: una crescita complessiva di quasi il 230 per cento. Lo shock negli Stati Uniti, ubriachi di benzina a basso prezzo, è stato terribile, tanto da bloccare la crescita, assieme alla crisi del credito, al crollo del mercato immobiliare e alla svalutazione del dollaro.
Scendono gli Stati Uniti, avanzano nuovi protagonisti. Oggi il mondo si può definire multipolare. La Cina, il secondo paese consumatore di energia, si è messa a competere sulle rotte del petrolio, trasformandosi in una potenza quasi neocoloniale in Africa e in Sud America. Per proteggere i contratti nei nuovi mercati dei paesi emergenti il governo di Pechino ha deciso di utilizzare la forza navale e aerea.
Secondo un rapporto del Pentagono, la Cina sta addirittura costruendo una flotta di cinque nuovi sottomarini nucleari intercontinentali, dotati di missili balistici.
Ancora più sorprendente è la resurrezione della Russia nel corso degli ultimi 18 mesi. «Il Cremlino ha scoperto che nel 21° secolo è più facile marciare attraverso l’Europa facendo business piuttosto che con l’Armata rossa» dichiara a Panorama Steve Levine, uno dei maggiori esperti della nuova geopolitica dell’energia, autore del recente best-seller Oil and Glory. «È un’altra dimensione nello spostamento del centro di gravità per quanto riguarda l’influenza globale verso est».
Nelle dichiarazioni ufficiali Stati Uniti e Unione Europea si oppongono ai piani russi di costruzione dei nuovi gasdotti. Eppure, chiede Levine, «chi sono i partner della Russia in questi progetti?
Germania e Italia. Il Cremlino usa la forza o la persuasione, a seconda degli interlocutori, per convincere società come Eni, Basf ed E.On a cooperare sia nei programmi del South Stream sia in quelli del North Stream. È il prezzo da pagare per avere accesso ai giacimenti di gas naturale russo».
Dopo aver onorato tutti i debiti, il governo russo ha aumentato il budget federale di 10 volte dal 1999, ha accumulato riserve in oro e in monete forti pari a 425 miliardi di dollari e ha creato un fondo di stabilizzazione di 150 miliardi di dollari. Il risultato è che il presidente Vladimir Putin e il suo probabile successore Dmitri Medvedev sono in grado oggi di reclamare il ritorno alla propria sfera d’influenza delle ex repubbliche sovietiche.
Non solo, hanno la forza per resistere al nuovo sistema di difesa missilistico voluto da Washington nell’Europa orientale e per affrontare in piena autonomia questioni scabrose come il nucleare iraniano e l’indipendenza del Kosovo.
Anche il venezuelano Hugo Chávez usa l’improvvisa ricchezza per allargare il suo raggio d’azione soprattutto in America Latina, dove può contare su alleati fedeli in Bolivia, Nicaragua e persino in Argentina. A Buenos Aires è esploso nelle scorse settimane uno scandalo politico per i presunti finanziamenti elargiti da Chávez alla campagna elettorale della vincitrice Cristina Kirchner.
All’improvviso, grazie ai 13 miliardi di barili del megagiacimento di Kashagan, dove ha un ruolo chiave l’Eni, il Kazakhstan rinnova il «Grande gioco» nell’Asia centrale pretendendo il ruolo di arbitro. Russia, Cina, Stati Uniti e Unione Europea corteggiano il presidente Nursultan Nazarbaiev e si contendono gli oleodotti. L’autocrate di Astana è abile ad accontentare ora una superpotenza ora l’altra, mantenendo sempre in equilibrio la bilancia del potere, ma badando a proteggere i propri interessi.
Per chiudere il contenzioso sullo sfruttamento di Kashagan, sollevato l’estate scorsa, Nazarbaiev ha ottenuto un bonus di 4,5 miliardi di dollari per i ritardi nella produzione e ha fatto trasferire l’8,5 per cento dell’intero progetto alla società petrolifera di stato KazMunaigaz, messa sullo stesso piano delle sorelle occidentali maggiori.
Anche la Turchia, centro nevralgico per il passaggio delle petroliere e degli oleodotti, ritorna agli antichi splendori sul palcoscenico internazionale, coccolata da molte diplomazie, prime fra tutte quelle americana e italiana.
In questa nuova geopolitica guidata dal barile di greggio c’è chi non si accontenta solo di contare di più, ma fa shopping strategico in giro per il mondo.
È il caso dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. «Questi paesi produttori vogliono un posto al tavolo dell’alta finanza» spiega Steve Levine.
Un recente dossier della società di consulenze McKinsey stima che gli investitori arabi del Golfo hanno ora in mano un immenso tesoro di proprietà sparse in tutto il pianeta per complessivi 3,8 milioni di miliardi. La sola Abu Dhabi investment authority, che ha asset stimati attorno ai 900 miliardi di dollari, ha oggi la stessa forza finanziaria della Banca del Giappone. Per salvare il colosso americano Citigroup sono dovuti intervenire sia il fondo di investimenti statali dell’emirato di Abu Dhabi sia il principe e miliardario saudita Alwaleed bin Talal.
I petrodollari (sempre più petroeuro) comprano tutto: influenza politica e grandi imprese. Il denaro dell’energia altera così i vecchi equilibri, ma non ne inventa di nuovi. Di certo il mondo si complica come negli anni della guerra fredda. Basta osservare quello che sta succedendo oggi nel Mare Artico. Russia, Canada, Norvegia, Danimarca e Stati Uniti reclamano la sovranità sui fondali del Polo Nord per poter sfruttare le immense risorse sottomarine. E, tanto per non perdere tempo, la Russia il 2 agosto 2007 ha pensato bene di anticipare le potenze rivali e di piantare la sua bandiera a 4.200 metri di profondità. -

Riciclaggio: nove miliardi di $ lavati nel software
| Italiasvegliati | Lunedì 23 aprile 2007 | Francesco Mangascià |
 In accordo con il Times News network, dieci businessmen indiani assieme ai loro complici europei, si son presi gioco della giustizia, con l’aiuto della First Curaçao International Bank, nonostante questa fosse stata interdetta nel Settembre del 2006, per le evidenze esposte dalle autorità del Regno Unito, grazie anche all’aiuto degli investigatori olandesi, che provavano la sua complicità nell’aiutare uomini d’affari europei e indiani, a riciclare il denaro sporco di uomini di affari europei e indiani.
In accordo con il Times News network, dieci businessmen indiani assieme ai loro complici europei, si son presi gioco della giustizia, con l’aiuto della First Curaçao International Bank, nonostante questa fosse stata interdetta nel Settembre del 2006, per le evidenze esposte dalle autorità del Regno Unito, grazie anche all’aiuto degli investigatori olandesi, che provavano la sua complicità nell’aiutare uomini d’affari europei e indiani, a riciclare il denaro sporco di uomini di affari europei e indiani.
Il percorso del denaro, ha rivelato agli investigatori che questa banca, ha spostato il denaro riciclandolo in diverse banche in tutto il mondo, inclusa la United Bank of Switzerland, UBS.
Mentre l’interdizione ricevuta obbligava la First Curaçao International Bank a sospendere i suoi affari in occidente, la stessa seguitava ad operare a Bangalore, sotto la copertura della Transworld ICT Solutions Pvt Ltd, un operazione di software, di proprietà di un olandese John Deuss, che casualmente era uno dei direttori della First Curaçao International Bank.
Quando gli investigatori indiani, hanno sequestrato il server della Transworld ICT, hanno scoperto che questa società di software era solo la foglia di fico, che doveva coprire ogni operazione di riciclaggio.
Questa associazione a delinquere transazionale, ha fino ad ora operato riciclando il denaro sporco all’interno di società che operano all’interno del mondo del software; secondo fonti attendibilissime, in pochi mesi attraverso queste operazioni sono stati riciclati 9 miliardi di $.
La stampa italiana da un po’ di tempo, lustri, non si può certamente definire una stampa dinamica, ma tacere anche adesso su certi consulenti e certe amicizie, significa essere anche conniventi.

